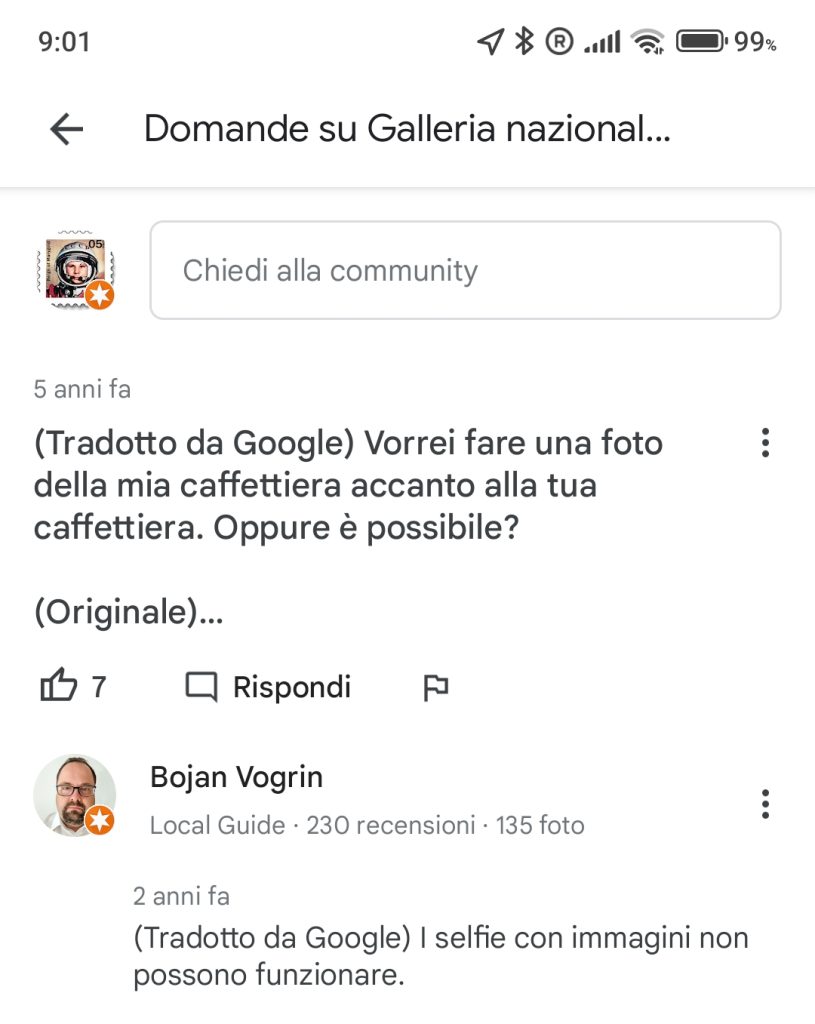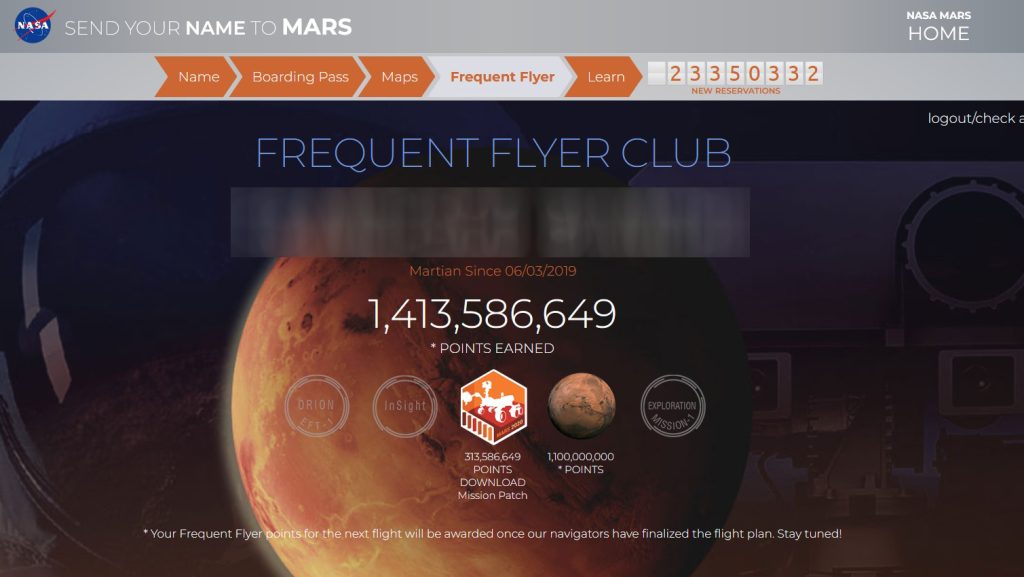Meritiamoci ’sto pasto, va’. Salgo su una delle colline attorno a Maribor, ricoperta di splendidi boschi appena sopra le viti. Dopo pochi minuti un cervo, un daino, un bambi con le corna insomma, mi salta davanti e scompare tra le piante inseguito ridicolmente da un cane. Madonna cone lavorano bene, qui, all’ente del turismo. E scommetto che io e il dainocervo ci rivedremo a cena, stasera. L’aria è alpina anche se, realmente, si è a soli duecentosettanta metri di altitudine e, in effetti, gli slalom alpini saltano sempre più spesso, in favore di Kranjska Gora e Adelboden. Ora ci sono quasi trenta gradi che, per quanto piacevoli con un’arietta fresca, son pur sempre parecchi.

Ci sono dei buffi cartelli che spiegano come su queste colline siano state reintrodotte delle viti di antica qualità per produrre un ottimo riesling del Reno, e io già qui faccio fatica, che ha vinto e vince molti premi. Buffi perché saranno almeno vent’anni, deduco, che nessuno mette mano alle viti, tutte ricoperte di rampicanti e rovi. Progetto europeo? Parlate, sloveni, perdio. Qui è davvero un ottimo posto per passeggiate, gite in bicicletta, escursioni per cantine, magari non il riesling renano, i prezzi son decisamente più bassi che a Lubiana. L’UE consiglia Maribor tra le destinazioni 2023, nonostante trascurino le viti, ed eccomi qua. Son così contento di non essere presidente del Consiglio e di dover fare le vacanze in Puglia blindato e, magari, dover fare una visita di cortesia in Albania a quel minchione del presidente, che piglio su le mie cose e me ne vado, libero e sereno, verso la frontiera austriaca, direzione Graz. C’è una cosa in particolare che voglio vedere, oltre alla città, bella di suo e già unescotutelata.
Oltre alla linea di demarcazione tra i bacini adriatici e del mar Nero, c’è un’altra linea che, grossomodo a questa latitudine, attraversa l’Europa da est a ovest, implacabile, immaginaria e reale allo stesso tempo: la linea sopra la quale c’è la patata e sotto il pomodoro. A un certo punto, impercettibilmente, i sughi, le insalate fresche spariscono e le patate lesse con il prezzemolo, arrostite se va davvero bene, conquistano ogni piatto. Insieme a quel subdolo silenzioso del cavolo, va detto, bianco o rosso che sia. Pochi chilometri prima potresti avere una bruschetta, per dire, fai due curve e se va bene bene si possono avere delle patate. Per carità, oggi in tempi di globalizzazione la cosa è men grave, un’insalata con due pomodori congelati si recupera in ogni dove, con i cambiamenti climatici la linea si sta pure alzando per cui il pomodoro arriverà in breve a Ratisbona, futuro luogo della dieta mediterranea, oltre che imperiale, però la cosa si sente comunque. Se sei dei pomodori, per quanto aperto e disponibile, tra le patate sarai sempre ospite e, dopo un po’, a disagio. Se sei della patata, prima o poi vorrai dominare il mondo per avere anche il pomodoro.

È ferragosto e non si capisce bene quali treni viaggino, così opto per la ‘freccia della Drava’, uno splendido intercity anni Ottanta originale con sedili tappezzati probabilmente da uno stilista di grido a oggi impunito, treno che va fino a Budapest, binario due ore 7:19. E ho anche l’occasione di apprezzare Maribor al minimo della sua popolazione. Pur rimanendo in Stiria, lascio la Slovenia per l’Austria, Maribor per Graz, la seconda città del paese che è governata, situazione inedita non solo in Austria, dal KPÖ, Kommunistische Partei Österreichs, con la compagna sindaca Elke Kahr. Che mistero la vita, eh? Leggo della morte di Alberoni, ricordo la rubrica del lunedì in prima pagina del Corriere, un cumulo imbarazzante di banalità, lo ritrovo in un reportage di Roncone al Twiga, seicento euro al giorno senza contare il cibo e diciassettemila all’anno di concessione allo Stato, in cui racconta che la moglie di La Russa e il compagno di Santanchè avrebbero acquistato la casa del sociologo e rivenduta nel giro di un’ora guadagnandoci un milione netto. Echi lontani qui in Stiria, per mia fortuna. Io vado da Elke Kahr, magari resto.
Graz è bellissima. Se Salisburgo è una scatola di cioccolatini per amanti della musica, Graz è Salisburgo sotto doping, più vivace e più grande. Tutte le cose al suo posto: bel fiumone tipo Inn, colline tutto attorno, collina dentro con castello sopra, cerchia di mura con meravigliosi parchi attorno, un centro intoccato che va dal medioevo al barocco passando per un cinquecento purissimo di ispirazione italiana che solo il castello di Cracovia, ottima posizione in ogni direzione, un bel festivalone musicale e teatrale.

Ma non basta. Nel mezzo del fiume qualcuno si è inventato un’isoletta artificiale tutta di metallo con un’arena per spettacoli, qualche locale, un museino; proprio di fronte, al posto di un vetusto isolato probabilmente di poco conto, è atterrato il friendly alien, come lo chiamano affettuosamente, il Kunsthaus Graz, il blobbone di Cook e Fournier.

Ora: il punto non è che piaccia o meno, secondo me. Il punto è se abbia senso e come si integri nel tessuto urbano e ancor prina sociale. Beh, quando la sera si illumina le persone, oggi me compreso, escono apposta per vederlo e stanno lì a bocca aperta, anche vent’anni dopo. Fichissimo. Prima che museo, non ha una propria collezione di arte contemporanea stabile, è uno spazio sociale e, mi pare, come tale è percepito. Bello? Brutto? Ognuno avrà la propria opinione, di fatto conta che faccia parte di un ragionamento ampio sulla città e i propri abitanti, sul presente e il futuro. Mi viene ovviamente da pensare al Maxxi a Roma – Hadid ha fatto cose anche qui -, abbandonato nel nulla di un quartiere senza prospettive, dato in gestione alla politica delle nomine, calato quello sì dall’alto senza un piano organico e, direi, dotato di umanità. Ecco, qui non pare, anzi, la Graz attuale offre grande vivibilità a ogni livello, il blob fa parte dell’offerta, chi vuole lo piglia.

Beh, se il certame è tra le città senza attrattive particolari – l’arena di Verona – ma affascinanti nel complesso, qui abbiamo senz’altro una nuova campionessa da podio, di prepotenza. Se unissimo a Graz le montagne attorno a Innsbruck, non dissimile per case e stile, andrebbe fuori scala. Per questo, al contrario del mio solito, qualche foto-cartolina per dare l’idea.

Ma qui c’è anche la compagna sindaca Elke Kahr, e ovviamente chi la vota, ed è la cosa che mi sconvolge di più, che per formazione politica è rivolta al problema casa e al reddito dei propri concittadini e io giro ebbro per una città che a me sembra già offrire una qualità di vita che noi, per davvero, ce la sogniamo da piuttosto lontano. Foss’anche solo che sto scrivendo sdraiato per terra nell’ennesimo meraviglioso parco, i cani cagheranno evidentemente da qualche altra parte, che la città pullula di posti che invitano le persone a stare – ricordate le panchine, pure senza dissuasore in mezzo? – e di iniziative delle persone per le persone. Avranno anche i loro problemi, non discuto e ne sono certo, ma al momento non saltano agli occhi. Voglio dire: ogni mezzo chilometro c’è un cesso di quelli chimici da cantiere, aperto e utilizzabile. Non sarà l’esperienza migliore del mondo ma, vivaddio, su questo si misura la civiltà prima che sulla gestione degli Imperii e l’esportazione della democrazia. Certo, è quello cui son sensibile io, ora. Ma nel 1938, all’entusiasta festa dell’anschluss, Hitler promise la fine della crisi economica e mille, mille!, anni di prosperità. Sette anni dopo i soldati sovietici entravano in città dopo quel che sappiamo. Partiamo quindi dai cessi e dalle panchine, un passo alla volta.
uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | otto | nove |