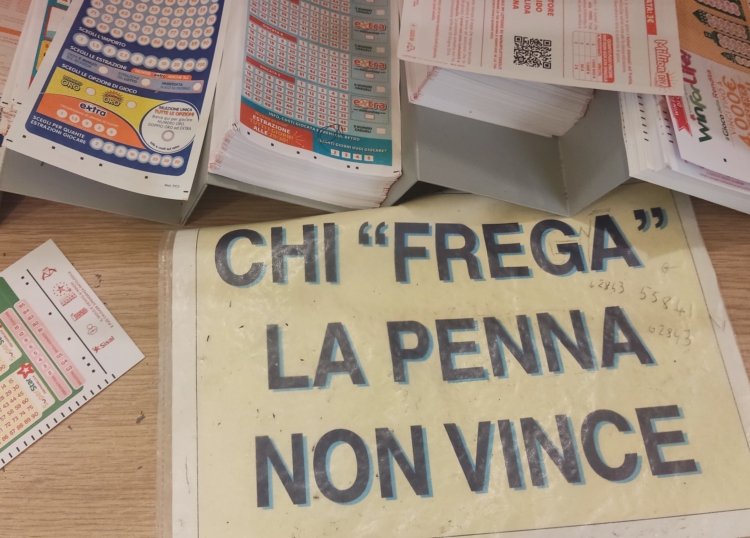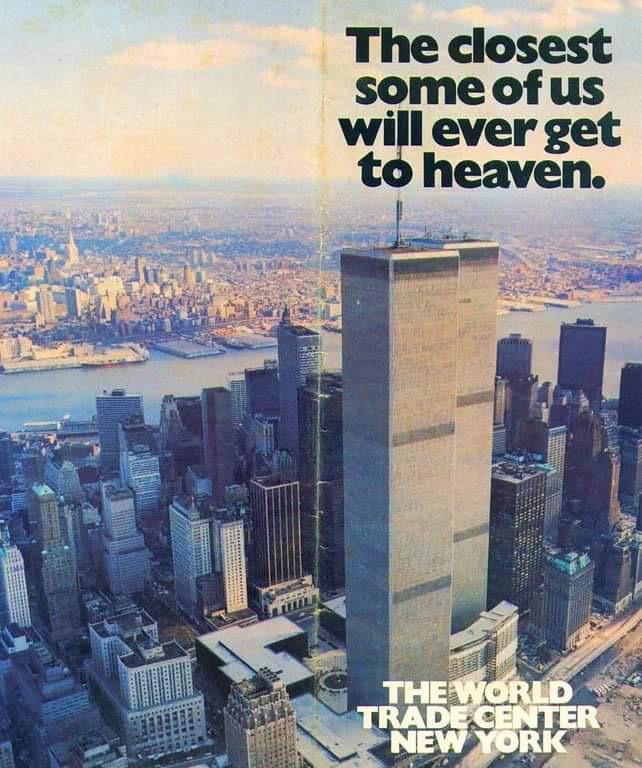Prosciutto e melone fa male? Pisolino quotidiano? A rischio infarto. Con la testa piena di questioni estive e prementi, parto per un altro dintorno. Non che le altre non lo fossero ma stavolta è una destinazione davvero da Grand Tour: Tivoli. Non è mica un caso se dalla Danimarca alla Bolivia i posti di ricreazione, bar, parchi gioco, giostre, ristoranti, li chiamano Tivoli quando vogliono far capire che il luogo è ameno. E non è, ovviamente, nemmeno un caso se di Tivoli parlano quasi tutti gli autori antichi e molti di essi ci si fecero costruire ville e ci vennero a scavallare l’estate. Perché Tivoli sta su una delle ultime colline verso Roma, poi è tutto piatto piattento, si vede lontanissimo, ed è anche alla fine della valle dell’Aniene, che lì fa uno svoltolone, un bel salto e poi scende giù e va verso la capitale. Insomma, verde, fresco e bella vista, gli ingredienti ci son tutti, basta evitare il melone col prosciutto, nel dubbio. Ah, Tivoli è pure più antica di Roma, si dice milleddue prima di cristo, immaginate gli sfottò nei bar. Secondo Dionigi di Alicarnasso fu fondata – eh, lo so, ho riso pure io ma non fa una piega – dagli aborigeni, cioè quelli che stavan lì fin dal principio, letteralmente. Noi li riteniamo Siculi, poi la storia andò come è facile supporre.
A Tivoli ci sono molte cose da vedere, io so già cosa non vedrò, perché merita una visita a sé con molta calma e il mio ricordo è ancora vivido: la sterminata villa di Adriano, ove l’imperatore si fece riprodurre il mondo conosciuto a suo diletto. Oggi, se tutto va bene, vedrò un paio di villone, una romana e una rinascimentale, un santuario usato per l’industria, un castellone costruito su un anfiteatro, un paio di templi, una cascatona e tante piccole cascatine, un paio di grotte, un’opera idraulica colossale, qualche belvedere, ovviamente il paese con le sue cose. Direi che è sufficiente. Insomma, vale il viaggio e varrebbe anche fermarcisi un paio di giorni, alla Goethe, per capire un po’ come funziona. Provo a raccontarlo anche se, lo so, di fronte alle cose entusiasmanti mi sfugge la brevità, ce provo.
Per restare a un tema di questo periodo e di questi miei giorni, l’acqua è un problema anche se ce n’è troppa, nel senso che entra in casa e ti porta via col letto compreso. L’Aniene è da sempre soggetto a piene torrenziali, è un fiume piuttosto grosso, e quello svoltolo nel centro del paese che la maggior parte del tempo è una delizia, talvolta diventa un problema. Plinio racconta la piena del 105 che si portò via mezzo paese. Per molto tempo si è cercata una soluzione finché nel 1832 l’ingegner Nonmiricordo propose a papa Gregorio XVI di scavare um tunnel nella montagna per far defluire il grosso delle acque al di fuori del paese, lasciando il vecchio corso, ormai placido e controllato, per le esigenze dei cittadini. Così si fece, si creò la grande Cascata, la seconda dopo quella delle Marmore in Italia, e l’opera idraulica diventò essa stessa motivo di visita a Tivoli, anche nel Gran Tour. Il vecchio salto del fiume, famoso per le sue ville, i templi, le grotte delle Sibille, nel dopoguerra venne utilizzato con saggezza come discarica. Ottimo. Oggi, grazie al FAI, la zona è recuperata e visitabile, e fate ’sta tessera, è la cosiddetta villa Gregoriana ed è una vera meraviglia, tra spelonche, resti romani, cascate, forre, templi e verzure. A un certo punto, col precipitare delle acque, ci sarebbe voluto persino un golfino, figuriamoci.

L’abbondanza di acqua è anche all’origine della scelta del cardinale Ippolito d’Este di farsi costruire una villa sontuosa proprio qui a Tivoli, forse sulle fondamenta di quella di Mecenate, che non sappiamo dove fosse. La particolarità di villa d’Este, che pure è meravigliosa e un esempio di Rinascimento insuperabile con un sacco di Zuccari, sono i giardini e soprattutto le fontane: si dice siano più di cinquecento, una da sola ha trecento cannelle, ce ne sono alcune gigantesche, altre minuscole, alcune hanno i pesci, una addirittura suona, c’è una scala tutta di marmo sul cui corrimano scorre l’acqua, insomma un trionfo di spruzzi, getti e schizzi. Il tutto in un parco ovviamente verdissimo. Il fragore degli scrosci è notevole, mi piacerebbe dormirci una volta, e il suono da solo basta a placare la sensazione di calura, come ben sapevano gli arabi. Io le giro tutte tutte e sono convinto di essere riuscito nel mio intento: mettere la testa in tutte e cinquecento.

Dopo tutta quella acqua, la realtà. Esco e il sole è azimutale e picchia con forza ma io devo vedere ancora una cosa almeno: il santuario di Ercole vincitore. Che è uno dei santuari, cioè tempione, criptoportico, aule eccetera, di epoca repubblicana più grandi della romanità. Bisogna scendere un po’ da una collina tutta brulla, un paio di volte ripenso a tutta quell’acqua così a portata di mano e mi chiedo se proseguire, poi noto poco avanti a me un uomo con zaino e sudore che sta evidentemente compiendo la mia stessa scellerata scelta, camminando di ombra in ombra. Alla prima curva attacco bottone, è Mirco (cappa?) e oltre a essere simpatico è pure archeologo, cosa meglio? Facciamo la visita insieme, che è sempre interessante. Del santuario resta pochino perché, oltre a essersi portati via i marmi come al solito, a un certo punto sul suo enorme basamento ritennero opportuno metterci prima una fabbrica di archibugi, “cose alla bresciana” le definisce il documento di fondazione e poi, vista l’acqua, una cartiera. Di quelle ottocentesche e pesanti. Quindi è una commistione di archeologia sia antica che industriale notevolissima ma dal punto di vista del santuario le cose son più complicate. Visto che già c’era l’acqua, causa cartiera, e le fondamenta, causa santuario, l’allora Enel vi installò una condotta forzata che ripigliava l’acqua in caduta da villa d’Este e delle belle turbine, che illuminarono sia Tivoli che, poi, Roma. Ancora bene ma ciao santuario. Poi la cartiera chiuse per conto suo, l’Enel mise un’enorme targa a celebrare la propria generosità nel chiudere la condotta nel 1993, che carini, e quel che rimane è questo enorme accrocchione di attività umane lungo duemila anni che viene visitato solo dai pazzi. Come pazzo sarà di certo diventato l’impiegato del museo dentro il santuario, dato che il museo, grande idea tipica di certi recuperi italiani, non è per nulla segnalato né si capisce che a un certo punto si possa entrare da qualche parte. Credo, dall’espressione, che potremmo essere le prime persone che vede da decenni, ormai fa parte dell’arredo come i pochi resti romani disposti nelle due stanze del museo. Facciamo due chiacchiere, gli consigliamo di non uscire e andiamo, in risalita. Ciao Mirco, grazie delle belle chiacchiere e delle spiegazioni sui tessuti murari, buona prosecuzione, lo saluto ed è buffo che vada a Caserta, al contrario del mio giro. Se per ventura ti dovessi leggere qui, perdona l’imprecisione del linguaggio archeologico.

Dopo tutta l’ubriacatura d’acqua di villa d’Este – il dato idraulico parla di ottocento metri cubi al secondo, moltiplicare per mille per avere i litri – è curioso che io cerchi un baretto per pigliare una bottiglietta d’acqua da mezzo litro e il ritorno a una realtà calda e piuttosto riarsa è difficile da mettere a fuoco. È uno degli aspetti tipici dell’acqua, esserci o meno, là dove c’è ce n’è molta, dove ovviamente non c’è non si scappa. Difficile si redistribuisca in modo uniforme, al di là del muro ce n’è da scoppiare, qua fuori sembra il Colorado. Il paese qui a fianco, Marcellina, non ha il fiume e di conseguenza ha da sempre un’economia e uno sviluppo del tutto diversi, meno floridi ovviamente. Di certo Orazio mica si sarebbe costruito la villa a Marcellina, con rispetto parlando. Son banalità, lo so, ma riflettere su ciò che si ha, o non, in modo piano serve anche a riconsiderare il valore di alcune cose e a non darle per scontate. L’acqua credo sia la più importante.
Eccomi qua, anche questo girolino è tutto sommato finito. Ci ho messo dentro qualche altro piccolo dintorno, Ponte Nomentano perché pur sempre di Aniene si parla, Sant’Agnese fuori le mura, luoghi che alla fine non son più nemmeno dintorni ma Roma stessa. Nonostante non avessi molti giorni disponibili, non si è trattato di un ripiego, tutt’altro, ho visto cose meravigliose e di grande qualità, persino con poco sforzo organizzativo e di movimento, e poi come si mangia in Italia, ah signora mia. Ho visto, come dicevo, pezzi di Grand Tour che i viaggiatori di un tempo sognavano una vita e potevano fare solo se ricchi e con del buon tempo, un’altra cosa fortunata della contemporaneità da non dare per scontata. Certo, ci sono anche le controindicazioni, per esempio stamane ho visitato il giardino di palazzo Colonna nel centro di Roma e l’ho trovato francamente piccoletto, una sola fontana miserina con una statuetta sghimbescia e uno spruzzino che nemmeno un rubinetto rotto. Eh già, villa d’Este mi ha rovinato i giardini di tutte le ville future e un po’ anche di quelle passate, retroattivamente, il confronto sarà quasi sempre impari. Vedi cosa succede ad andare in giro? Sto celiando, ovviamente, vedere il meglio è già di per sé una fortuna e per arrivarci bisogna vedere molto del resto, quindi tutto bene. Altrimenti non ce ne si accorge. L’idea per me, sempre di più, è fare viaggi sulla base di un progetto, anche minimo, e questo era i dintorni, diciamo, di Roma, a un’ora di distanza. È andata molto bene, non poteva che essere così, l’importante, credo, in questi casi sia fare il meglio che si può con ciò che si ha a disposizione. E quel che si ha, che si può avere se possibile, alla fine sono cuore e un po’ di entusiasmo. Il posto, la distanza o il dintorno non contano.