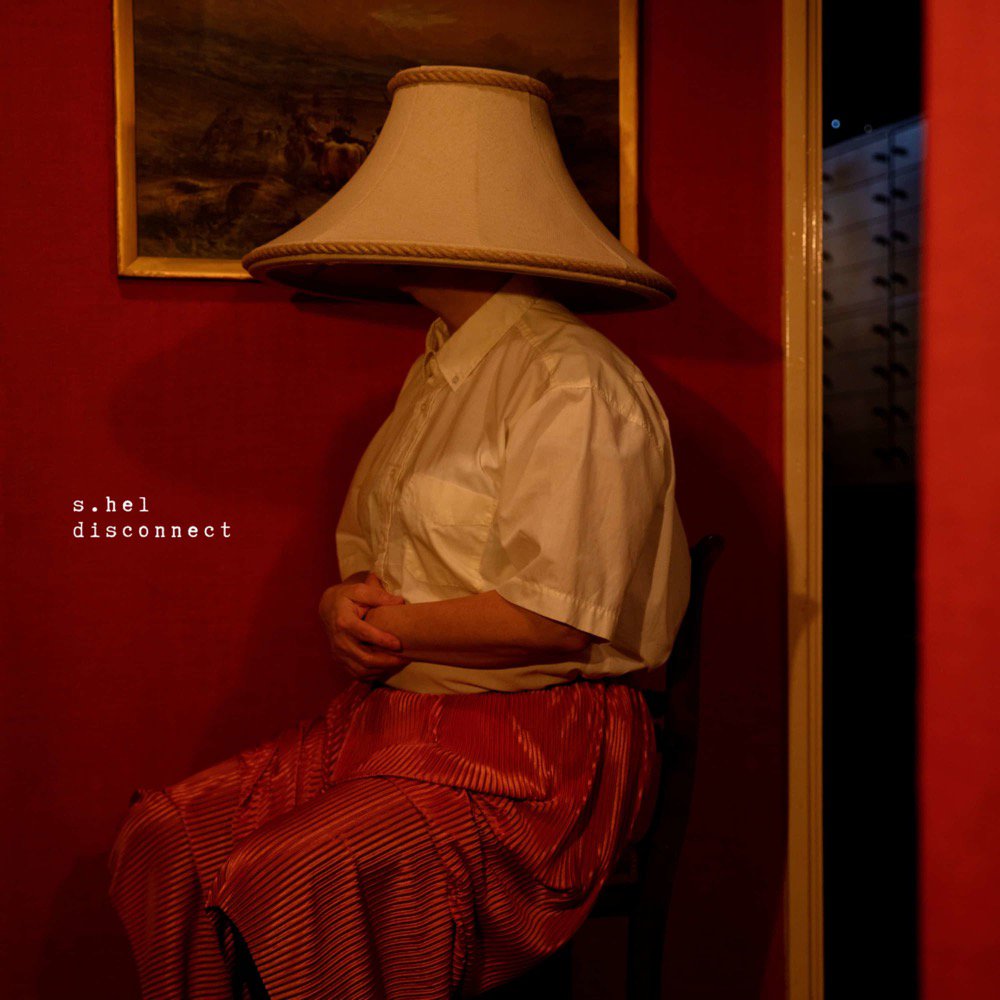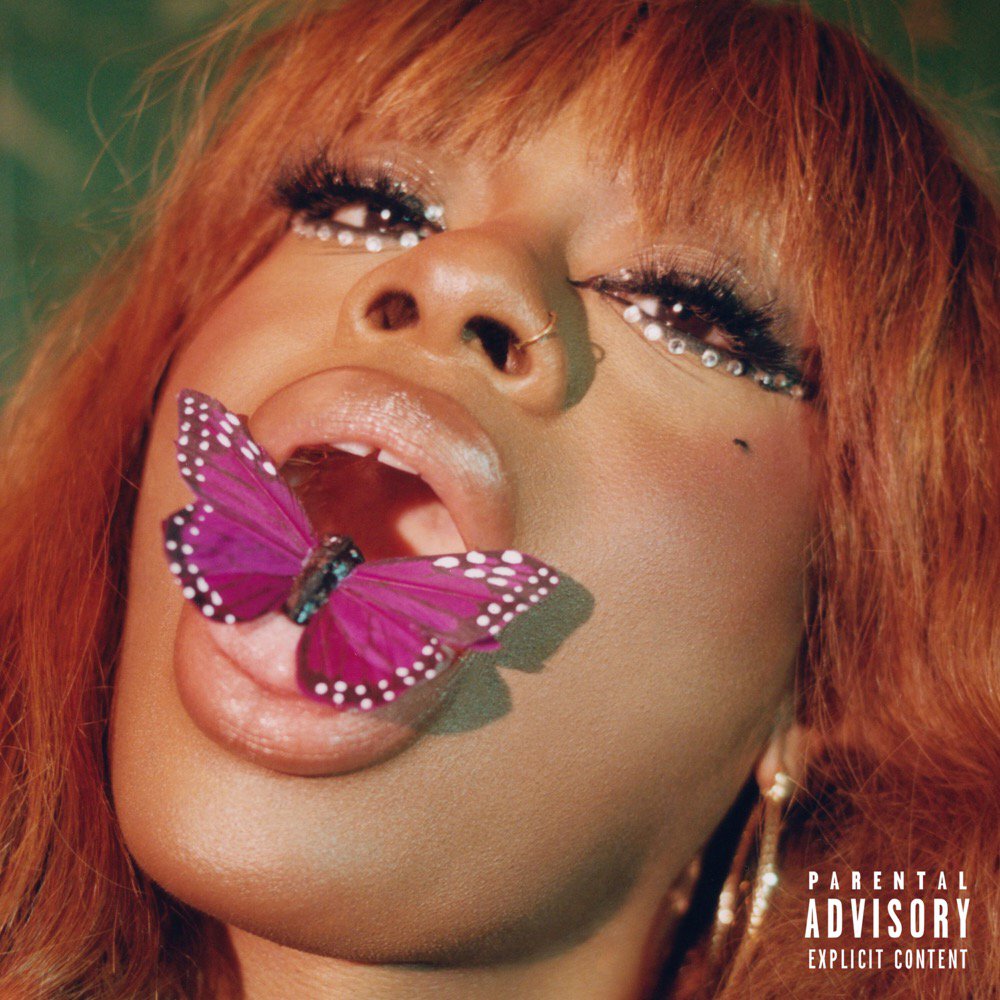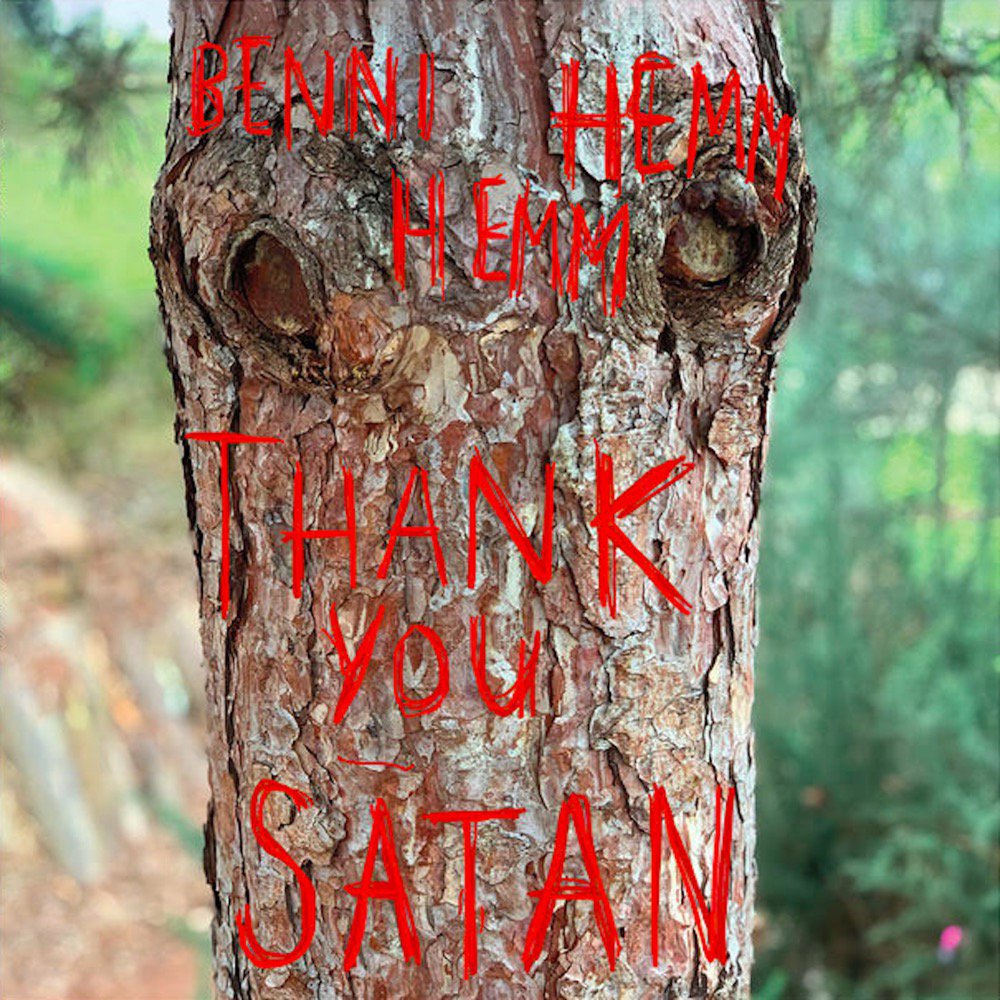Oggi giornata di grande attività: cavi alla mano, si è trattato di rimettere in moto un’auto in cortile che nei cinquanta giorni aveva perso la scintilla. Grande fervore, cavi, motori, brum brum, pareva quasi una vita fa. Pure la pioggia a lavare le auto, una meraviglia. Una volta messa in moto, ho accluso gita dall’elettrauto (giustificazione: sia di necessità sia il mio codice ATECO che è tra quelli legittimati alla circolazione) e ho dovuto fare per forza qualche chilometro per ricaricare la batteria. Un giorno pieno di cose. Che stanchezza, a sera. Che succede, oggi? Fitch declassa il debito dell’Italia a BBB-, che è appena una tacca sopra l’umido per il compost, chiaramente reagiamo dicendo che non hanno capito. Il governo ha imposto un prezzo calmierato per le mascherine, cinquanta centesimi al pezzo, e le farmacie che le hanno pagate di più ora si rifiutano di venderle. Bene. Il percorso dell’app per il tracciamento ha finalmente preso una piega istituzionale con un, minimo ma necessario, controllo sui dati raccolti che, pare, saranno cancellati alla fine dell’anno. Va ben pur tutto, va bene l’emergenza, ma che una società privata tra i cui soci ci sono i figli di Berlusconi raccolga con un’app i dati sanitari degli italiani senza che si possa esprimere almeno perplessità, è davvero un po’ troppo. I sondaggi degli umori politici degli italiani dicono grande fiducia a Conte e discesa costante della Lega, data adesso al 25,6% suppergiù (qualcuno con una buona battuta ha detto: «la discesa del contagio»). Salvini sbanda e non sa come riconquistare l’attenzione, ci ha provato mettendosi gli occhiali, facendosi la barba, postando il video della figlia che suona, strepitando contro il MES, facendo il versipelle ancor di più e invocando prima la chiusura poi l’apertura poi la chiusura e poi l’assoluzione per infermità mentale ma a nulla sono valsi gli sforzi. Intanto, spalleggiandosi con l’amico e sodale Renzi, lavora a indebolire il governo ogni volta possibile. Anche la Meloni, certo, ma è la meno convinta dall’ipotesi di un governo di unità nazionale con dentro tutti. Ovvio, lei al governo ha solo da perdere. Se poi è costruttivo, manco dipinta.
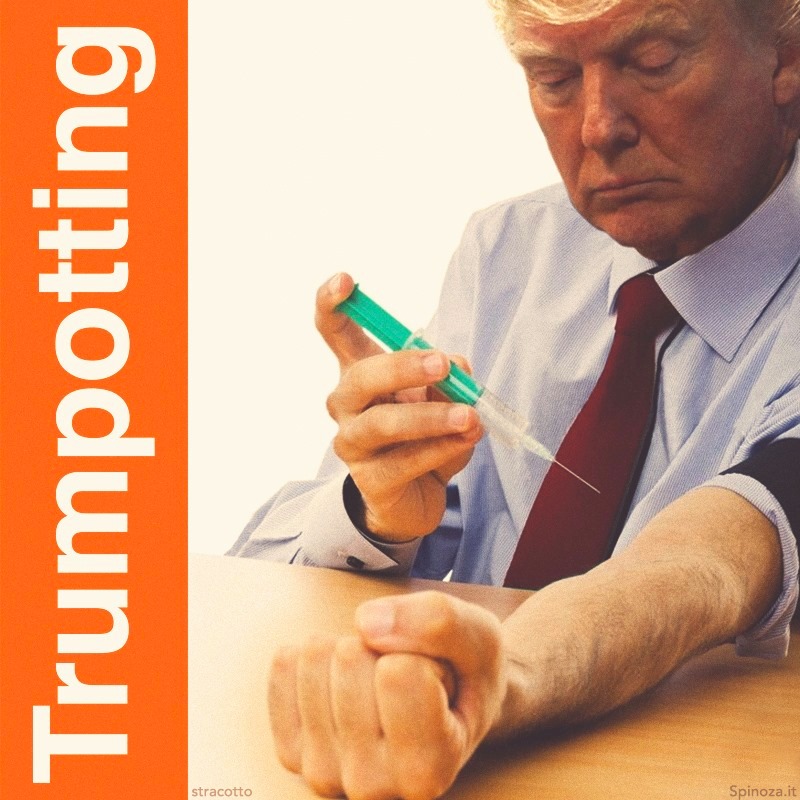
Al di là delle critiche al governo – Confindustria accusa il poco coraggio, CEI come detto di non riaprire le Chiese, le categorie di far finire sul lastrico i commercianti – c’è una critica legittima da fare: la mancanza di un piano sanitario per la «Fase 2». Mentre si parla di «congiunti», di sport, di seconde case, nessuno parla di un piano organico che includa i tamponi e i test sierologici, nessuno comunica le forme di una condotta omogenea, o eterogenea su base territoriale, che con chiarezza esplichi quali saranno i prossimi passi per affrontare la pandemia. Forse, tra le priorità, certamente dopo i nostri amici cani e gatti e i le uscite dei bambini, se ne potrebbe parlare. Anche perché, a oggi, è del tutto oscuro quanto duri l’immunità (pare poco) e se sia possibile essere infettati nuovamente (sì) e qualcuno sostiene che il virus sia già mutato trentatré volte dalla Cina in poi. Quindi, prima delle gite al lago, forse bisogna affrontare altro. Per domani è attesa una circolare, vedremo cosa si dice. Al momento non è ancora chiaro di chi sarà la competenza e il dovere di stabilire delle nuove zone rosse in caso di nuovi contagi dopo il 4 maggio, se del governo o delle Regioni. Sarà il caso di capirlo, visto che pare sia uno dei cardini delle prossime strategie.
I giorni precedenti:
giorno 52 | giorno 51 | giorno 50 | giorno 49 | giorno 48 | giorno 47 | giorno 46 | giorno 45 | giorno 44 | giorno 43 | giorno 42 | giorno 41 | giorno 40 | giorno 39 | giorno 38 | giorno 37 | giorno 36 | giorno 35 | giorno 34 | giorno 33 | giorno 32 | giorno 31 | giorno 30 | giorno 29 | giorno 28 | giorno 27 | giorno 26 | giorno 25 | giorno 24 | giorno 23 | giorno 21 | giorno 20 | giorno 19 | giorno 18 | giorno 17 | giorno 16 | giorno 15 | giorno 14 | giorno 13 | giorno 12 | giorno 11 | giorno 10 | giorno 9 | giorno 8 | giorno 7 | giorno 6