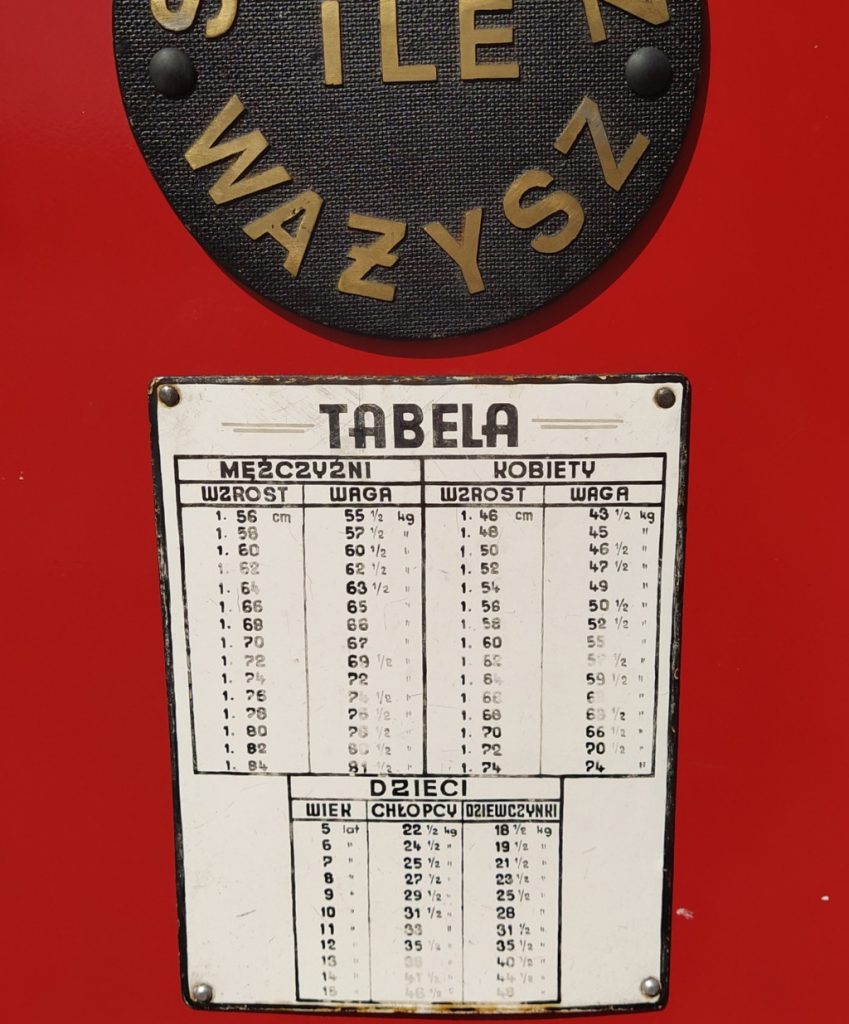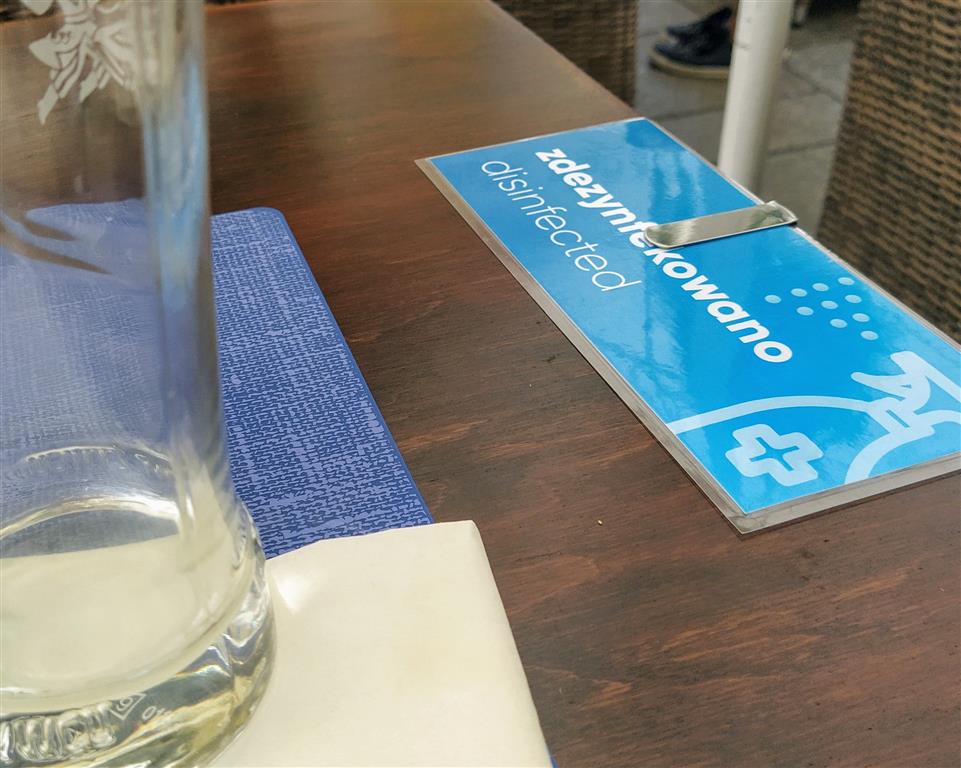Piove, grigio e tira vento. Sono a Brema e non è evidentemente, un caso: in alcuni dialetti della val padana la brema è il freddo e, in effetti, così è. Certo, in trevisano la brema è il documento, il che potrebbe far vacillare la mia solida congettura, ma non posso certo occuparmi di tutto io. Piuttosto, già che ci sono vorrei sgomberare il campo dai fraintendimenti in cui sono occorso pure io medesimo: «il pifferaio di Hameln» (italianizzato in Hamelin, «Der Rattenfänger von Hameln»), o «il pifferaio magico» non c’entra nulla con Brema. Stava, appunto, a Hameln, in Bassa Sassonia. Storia tragicona, tra l’altro, mica bazzeccole. A Brema, invece, c’erano i musicanti di Brema («Die Bremer Stadtmusikanten») e l’unica analogia tra le due storie è l’essere entrambe state raccolte dai Grimm. La storia dei quattro musicanti racconta la vicenda di un asino, un cane, un gatto e un gallo che, stufi di venire maltrattati nelle reciproche fattorie, scappano insieme verso Brema con l’intento di diventare musicisti e, mettendosi insieme e unendo le forze, riescono a occupare una casa, a sfamarsi e a sfuggire all’attacco dei briganti. Che confusione.

Prima di arrivare in un posto, una città, una regione, uno stato, mi piace provare a riassumere mentalmente tutto ciò che conosco di quel luogo, qualsiasi cosa. Di Brema ho richiamato: erroneamente il pifferaio, faccio ammenda; il «magico 4 per 4 del circo di Brema» di De Gregori (la canzone è «Ninetto e la colonia») che chissà che vuol dire ma ha magari a che fare coi musicanti (e comunque poi apparve un pellegrino vestito di chiffon); il Werder, vabbè. Non molto, in effetti, non mi viene in mente nemmeno qualcuno nato a Brema o che ci abbia fatto qualcosa. Ignorante perché ignoro.
Ignoravo anche l’esistenza del Rolando (Orlando) di Brema, ovvero una statua medievale alta cinque metri che occupa la piazza principale della città e simboleggia la libertà e l’autonomia della libera città di Brema (che è una città-stato, tra l’altro). Ovunque in Europa si trovano spade d’Orlando, conficcate o per toponomastica, ovunque riferimenti a lui o ad altre figure della Chanson, per esempio il perfido Gano di Maganza, e scopro or ora che in alcune città tedesche (Quedlinburg, per esempio) vi sono statue a lui dedicate. Credo che il nesso sia Carlo Magno. A Roma, per citare un esempio locale, esiste uno stretto vicolo a fianco del Pantheon nel quale, secondo la leggenda, la spada di Orlando, la Durlindana, si sarebbe conficcata dopo un lungo lungo volo. Il «vico della spada d’Orlando», per l’appunto, bella storia. La statua di Brema protegge i viandanti che si presentano al suo cospetto e garantisce un viaggio sicuro. Eccomi, anche se alla fine invece che all’inizio.

Una delle certezze della Germania – una bella certezza per un viaggiatore – è che, inviariabilmente, sotto qualsiasi municipio di una qualsiasi città tedesca si può trovare a colpo sicuro una ratskeller, di solito di origine medievale, ovvero una cantina in cui mangiare carnazza con patate e crauti, bere vino e condividere tavoli. Ma proprio proprio sotto il municipio, ne è sempre parte integrante. Il che colpisce chi vien da fuori ma, riflettendoci un secondo, tutto sommato è un ottimo riflesso, diretto, delle politiche sociali comunali. Usanza da importare, fossimo meno rigidi su queste cose.
Bel centro, Brema, quel che è rimasto da un bombardamento insistito come pochi, era pur sempre un porto strategico tedesco nel mirino degli Alleati, diciamo che una mezza giornata la merita senz’altro. Ed è quello che faccio io, poi piglio su baracca, burattini, zaini, animali e flauti e mi metto in viaggio verso casa. Porto con me parecchio anche da questo viaggio, ho messo a posto nella mia testa alcune zone d’Europa che non mi erano chiare, ho visto gente e fatto cose, ho imparato qualcosetta e mi sono parecchio svagato. Mi sono divertito a scrivere questo minidiario come mi sono divertito a leggere e a rispondere – quasi sempre – ai commenti di chi ha voluto partecipare, grazie a loro; spero di aver suscitato qualche sorriso qua e là, non sempre un lavoro quotidiano riesce ad avere la medesima intensità, anzi. Ci sono, ora è tempo di far fagotto e ci vediamo, magari, in giro.
giorno zero | giorno uno | giorno due | giorno tre | giorno quattro | giorno cinque | giorno sei | giorno sette | giorno otto | giorno nove | giorno dieci | giorno undici