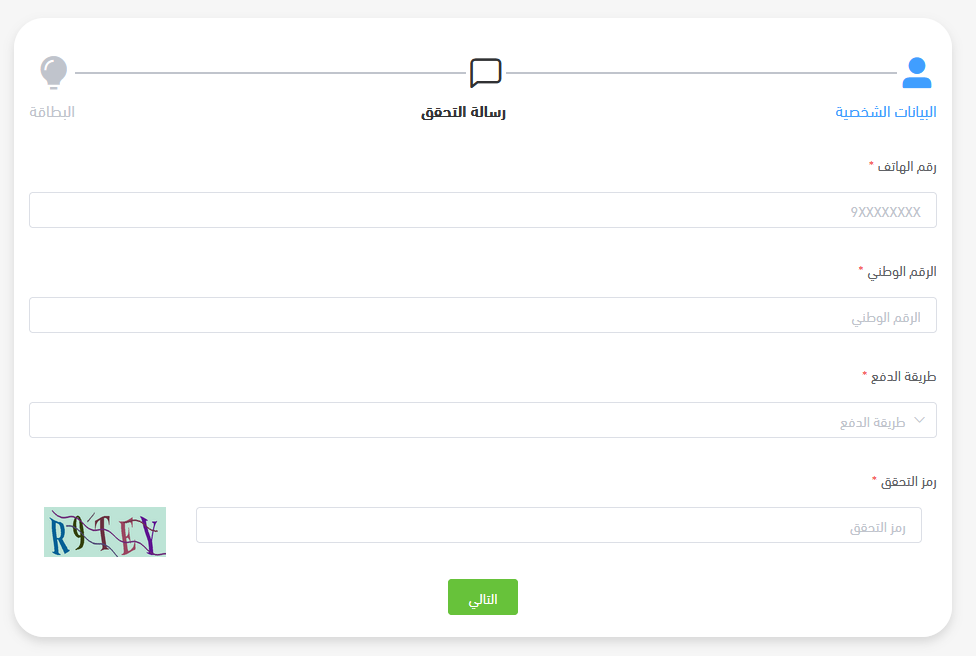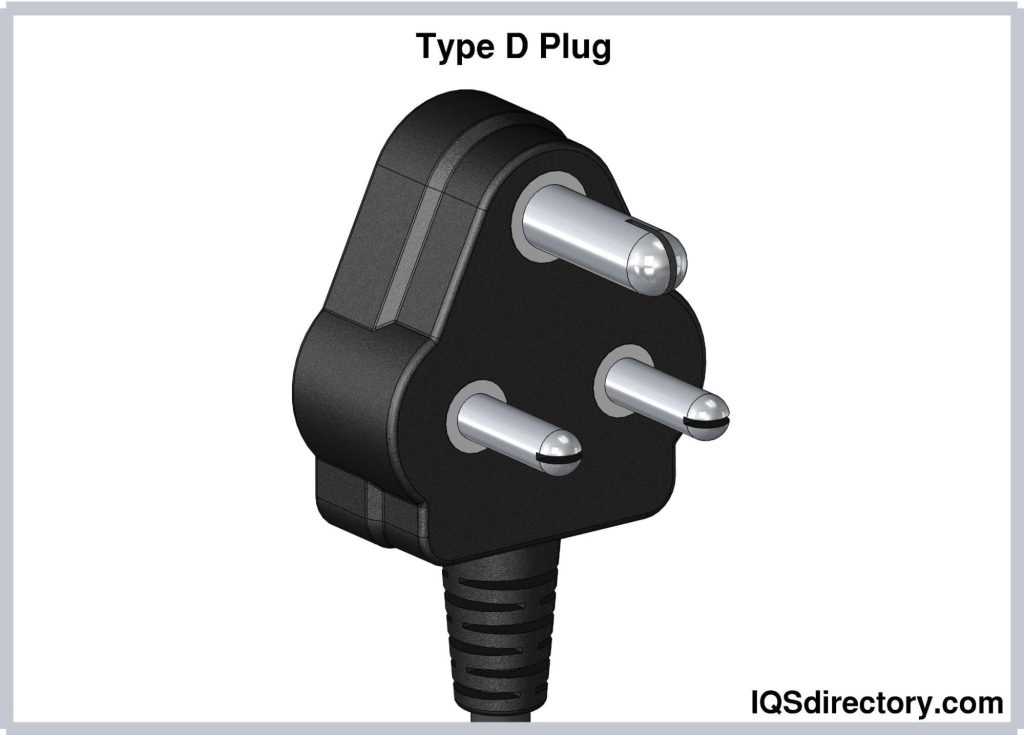Il piano per quanto possibile è di girare un po’, per vedere l’effetto che fa. E se di Tripolitania si tratta, allora bisogna vedere almeno le tre città: la prima, Oea, oggi Tripoli, un po’ s’è dato, ci sarà tempo alla fine; la seconda, Leptis magna, la città imperiale di Settimio Severo, è la meta di oggi. Così possiamo vedere i centoquaranta chilometri di paese che la separano a est da Tripoli. Per carità, ci si vuole andare, ci mancherebbe, ma la destinazione turistica è anche una buona scusa per snasare in giro. Domani ancor più. La strada litoranea, la strada degli italiani, la Balbea che da Tripoli va fino a Tobruk dall’altra parte, è una camionabile a due corsie per percorrenza punteggiata di dissuasori alti così, una vera passione in Nordafrica. Alla corriera non entra la prima fin dalla prima periferia e a nulla servono le doppiette dell’autista; la leva del cambio sarà lunga sessanta centimetri, minimo, e questo pullmino avrà visto il re Idris se non il governatore italiano. Non meno dei dissuasori, i posti di blocco e i blindati al ciglio della strada. Il più delle volte nemmeno fermano ai blocchi, talvolta salgono in due, spesso uno in divisa, li preferisco, mi sembra che almeno due regole le abbiano, e uno in borghese, maglietta e scarpe da ginnastica, scrutano e guardano tra i sedili, poi scendono spesso senza una parola. Capire ogni volta di che banda siano immagino sia difficile anche per un libico.

“Comunisti”, dice Adel, il libico che ci accompagna, “Prima erano tutti comunisti, con quel comunista di Gheddafi”, si scalda. I comunisti, lo spauracchio di tutto il pianeta, ma ce ne fossero, almeno. Vero che il regime di Gheddafi, come spesso accade, qualche elemento socialista almeno di facciata nella prima parte dei Settanta, erano anni così, l’aveva. E sosteneva l’OLP di Arafat. Ma da qui al comunismo, ciao, Adel. E poi parte una filippica sull’attuale situazione per cui mi chiedo come mai i barconi non vadano nella direzione opposta, dall’Italia alla Libia: stipendi sontuosi per insegnanti e chi abbia voglia di fare, cicli scolastici tutti gratis, lavoro per tutti, automobili nuove e, come disse quello là, ristoranti pieni. E strade nuove costruite dai tedeschi, alberghi, grande ripresa lanciati verso la guida del mondo arabo. Quando arriva a dire che adesso adesso il presidente – non uno dei due, IL – indirà nuove elezioni perché il popolo stabilisca liberamente la forma di governo che desidera avere (dice monarchia, repubblica, anarchia) mi vien da ridere e smetto di ascoltare. Pubblicità di mattoni forati lungo la strada, il 20×40, il 24×36 e il 20×30, probabilmente il migliore. Ho appreso da poco che il piede greco era 29,6 centimetri e la coincidenza con l’A4 mi commuove.
Leptis magna è una città romana imperiale formidabile, enorme, prima punica e poi cartaginese. Ebbe oltre centomila abitanti sotto Settimio Severo, nato in città, fu all’altezza di Atene e Roma. Le rovine sono molto integre, grazie alla sabbia e all’abbandono, non vi furono costruite città sopra. Gli ultimi scavi, come praticamente ovunque in Libia, furono italiani durante il ventennio, si vedono ancora i binari con i carrelli per i lavori. Anche i musei, ovviamente chiusi, sono razionalisti o, al massimo, inizio modernisti. Gli scavi non solo non procedono ma sono fermi a percentuali minori, forse la metà della superficie della città. E fin qui le informazioni. Sicuro non si vedono stranieri da tempo, qui, il sito non è recintato, non c’è una vera biglietteria, nessun pannello esplicativo, i bidoni dei rifiuti traboccanti, volessi portarmi a casa un capitellone, non fosse per il peso, potrei. Impressionanti le dimensioni, il foro con tempio in testa e basilica in fondo è colossale, l’anfiteatro enorme e, con colpo di genio, prima cava e poi spazio pubblico, l’arco di SS con frontone tagliato un ardimento architettonico clamoroso, pura fantascienza contemporanea. Mio padre c’era venuto vent’anni fa, con tanto di libretto verde, mi riportò osservazioni analoghe, mi era rimasto il desiderio. La città, come l’altra della triade della Tripolitania, fu abbandonata alla caduta dell’impero d’Occidente perché, soprattutto, il porto si insabbiò. Mai nessuno che ascolti Vitruvio. La guida locale parla un italiano perfetto con proprietà e competenza, qui tutti qualche parola la sanno, i vecchiotti parlano.

Al ritorno è una sequela di posti di blocco, non sono avvezzi agli europei e stranieri in generale, per alcune generazioni di bimbi siamo sicuramente tra i primi, è solo da gennaio di quest’anno che hanno riaperto i voli. Mi inquieto un po’ quando salgono due armati, vestiti completamente di nero con passamontagna e tuta protettiva, a metà tra black block e swat. Non lo colloco, difficile farlo, le attrezzature e l’auto sono nuovi e costosi. Si limitano come gli altri a guardare tra i sedili, cercando immagino persone nascoste. Mentre aspetto e sbircio di sottecchi, ripasso la storia coloniale italiana in Libia: l’inizio è liberale, con Giolitti, il cui governo intraprese una guerra che di fatto fu combattuta prima contro la resistenza anti-coloniale turco-libica e poi solo libica. Con il trattato di Ouchy, nell’ottobre 1912, Costantinopoli si impegnò a ritirare i propri ufficiali e la Libia poté essere annessa all’Italia. Se durante la prima guerra mondiale la presenza italiana fu respinta in poche zone lungo la costa, dal 1922 con il fascismo fu intrapresa una lunga campagna di conquista per la repressione dei ribelli e dei civili libici durante la cosiddetta “riconquista della Libia”. Nel 1934 Cirenaica e Tripolitania furono unificate nel governatorato generale della Libia italiana. Cioè Balbo. Nel frattempo, i tizi neri neri scendono e se ne vanno. Bene. Poi il pullmino si rompe, quelle marce lo dicevano da un bel po’. Ma siamo a cinque chilometri da Tripoli, giù e si può fare a piedi.