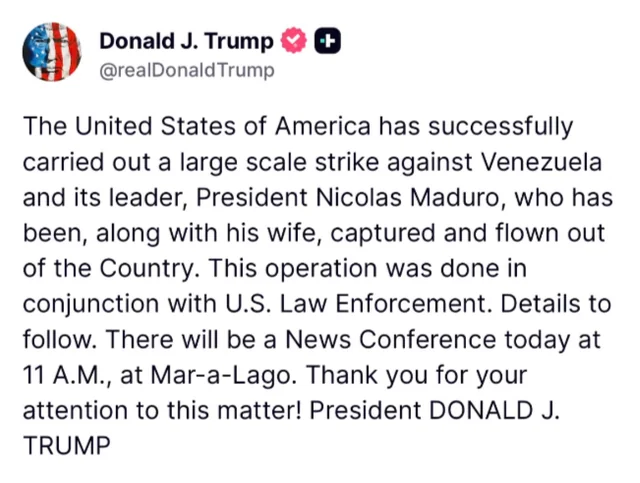Ho già proposto una guidina con tre motivi per andare ad Amburgo, la città forse più vivace e affascinante della Germania a parer mio – ed è ancora così dopo esser stata rasa al suolo dagli Alleati, figurarsi prima -, in cui passare dei lieti giorni e sentire concerti a raffica. Oggi vorrei proporre una camminata lunghetta, a volte noiosa, a volte un filo impervia nel porto di Amburgo che però riserva soddisfazioni notevoli, ad aver gusto per queste cose. Se no, andare alle guide con le ‘cinque, sette cose imperdibili ad Amburgo’ e dilettarsi di là. Via.
Metropolitana fino alla fermata più bella e caratteristica del lungofiume, Landungsbrücken, poi qualche minuto a piedi verso ovest per imboccare il tunnel che passa sotto l’Elba: l’Alter Elbtunnel. Lungo mezzo chilometro, fu costruito per agevolare il percorso ai lavoratori del porto della città negli anni Dieci del Novecento: bellissimo, ancora ricoperto delle piastrelle originali, sì quelle che ogni ristorante di Manhattan ha copiato, e con ascensori, porte, maniglie, targhe originali. Ne vale la pena, bici o piedi. Da qualche anno, grazie, è chiuso alle auto.

Fedele alle mie funzioni di servizio, le mie foto. Niente filtri, era nuvoloso e grigio quel mio giorno, queste sono. Cosa peraltro molto affine al giro che vado proponendo. Usciti di là vi aspettano cinque bei chilometri di camminata lungo i canali e i capannoni del porto di Amburgo, il secondo o terzo d’Europa (chiedere ad Anversa), ancora perfettamente attivo. Eccitante? Non credo. Ricco di photo opportunities? Ma manco per caso. Un’occhiata da sotto, forse, al Köhlbrandbrücke, il colossale ponte, è l’unico momento che potrebbe apparire su una guida tradizionale. Ma è porto vero, enorme terminale in cui arrivano tutte le minchiate che gli europei comprano dalla Cina e dal mondo per poi essere distribuite, ogni container ne contiene parecchie.
Dopo un’oretta di cammino ad angoli retti – attenzione che a ogni ponte sbagliato equivale una mezz’ora in più, per aggirare i bacini di carenaggio o di scarico -, piuttosto gradevole per chi come me ha piacere dei cantieri e dei luoghi di lavoro industriali, si comincia a intravedere la destinazione, essendo piuttosto colossale: la flakturm V di Amburgo.

Ovvero una delle due gigantesche torri antiaeree di Amburgo. L’altra, quella fighetta della IV, sta a nord, ci vanno tutti, ci sono anche le camere affittabili per fare l’esperienza e, cosa divertente, c’era dentro un tekno-klub negli anni Ottanta che ovviamente non disturbava nessuno. Questa no, non ci viene quasi nessuno ed è lì, intonsa. Le flakturm, come dice il nome, sono enormi torri antiaeree costruite dai nazisti, tre a Berlino, tre a Vienna e due qui, talmente grandi e dai muri spessi di cemento armato compatto da essere pressoché indistruttibili. O, meglio, servirebbe tanto esplosivo da non valerne la pena: gli Alleati si cimentarono con una di quelle di Berlino e per raderla al suolo ci misero quantità spropositate di qualsiasi cosa. Le altre, quindi, stanno lì. Servivano non solo come difesa, sul tetto c’erano armi pesanti, ma anche come rifugio e custodia, specie di bunker emersi da terra.
Questa è stata riconvertita in una centrale energetica, mostrata spesso anche a scopo didattico, ed è al centro di un parco ricreativo in una zona non troppo confortevole per la residenza. In cima c’è un bar che mi ha dato grande soddisfazione una domenica mattina, per un caffè sul terrazzo della torre a scrutare l’orizzonte.

Per sua stessa natura e scopo, la flakturm è costruita come una torre-scatola vuota e il momento più divertente della salita al tetto è quando si prende l’ascensore:

A che piano?
Certe città si capiscono solo vedendo ciò che le caratterizza, in una città portuale bisogna vedere il porto. Sembra banale ma non lo è, alla fine spesso si cercano le stesse solite cose in ogni città e le città stesse tendono a proporle, inventandole se non le possiedono: i ristorantini, i localini, i museini, i negozietti, perché quello evidentemente chiediamo. Ma se volete capire un po’ di più Amburgo, come lo volevo io, allora una bella camminata addentro il porto con splendido tunnel e impressionante torre residuo del tremendo passato vi regalerà senz’altro ciò che cercate.
Le altre guide:
adda (risalire da trezzo) | amburgo (tre motivi) | amburgo (le cose vere) | berlino (in sei mosse) | bernina express | bevagna | budapest (gerbeaud) | edimburgo (tre cose per una notte) | ferrara (le prigioni esclusive del castello estense) | glasgow (caffè e tombe) | libarna | mantova (la favorita) | milano (cimitero monumentale) | milano (sala reale FS) | milano (tre abbazie) | monaco di baviera (nazismo e resistenza) | monza e teodolinda | tre giorni in nederlandia | oslo | pont du gard | prietenia: l’ultimo treno sovietico | roma (attorno a termini) | roma (barberini) | roma (mucri) | roma (repubblica) | roma (termini) | da solferino a san martino (indipendenza) | torino (le nuove) | velleia | vicenza (l’illusione della regolarità)