
Mapporc. Rialzo la testa, guardo di nuovo.

Eh gnente, han proprio fatto il segno, chissà che vien giù ora.
O ci han messo una croce sopra e bon, saluti a tutti?
Grazie al signor E.


Mapporc. Rialzo la testa, guardo di nuovo.

Eh gnente, han proprio fatto il segno, chissà che vien giù ora.
O ci han messo una croce sopra e bon, saluti a tutti?
Grazie al signor E.
Marò, i Marillion.
Chiariamo, come se servisse dirlo: con Fish, gli unici Marillion che io conosca. Ovvero: Script for a Jester’s Tear, Fugazi, Misplaced Childhood e Clutching at Straws. E Real to Reel e The Thieving Magpie, cioè cinque anni scarsetti.

Chiaro che genesiseggiavano, bella scoperta, e che lui gabrieleggiava, indovina. E allora? Tutti inventori di cose nuove? Ovviamente no, l’impianto era davvero solido, musicalmente, vocalmente e dal punto di vista compositivo, mica per caso si chiamò neoprogressive. Diciamo sentirli nel 1984 a Sheffield, quando annuncia una nuova canzone intitolata Fugazi, oppure all’Hammersmith Odeon nel 1986 ma certo non butterei via Edimburgo nel 1987.
Di concerti ne ho visti tanti ma ne ho mancati molti, molti di più.
10.000 Maniacs, Crosby, Stills and Nash, Dire Straits, Marillion, Natalie Merchant (recuperato, tre volte), No Doubt
È quasi tempo di una comoda lettura dei giornali a piazza Bernini, un panino con affettati appena affettati, appunto, all’alimentari, una visita a San Saba, un pensiero alle case popolari di Polverini ma no, perché rovinarsi la mattina? e, magari, la discesa sulle terme.

Oppure no, giù di là verso casa, vicino all’Aventino quello vero.
Finisce l’inverno e la cosa importante non è la luce, il caldo, le foglie, i fiori, l’amore: la compila.
Ecco le settantasei canzoni della stagione appena conclusa, quasi una al giorno e, se dovessi azzardare una valutazione, direi boh. Vivo proiettato verso il futuro, che ne so io del passato? A me piace, ovvio, ci mancherebbe non lo facesse, sarei stolto: si apre con un classico dance settanta, però nella versione rock Blue Man Group con la grande Venus Hum, per chiudere con una nuova uscita, il singolo dei Vampire weekend. E si pregusta un tour, immagino. In mezzo c’è anche roba truzza, come sono io sovente.
A proposito: concerto della mia stagione è stato senz’altro Alison Goldfrapp al Barrowlands Ballroom di Glasgow, che divertita con gli amici scozzesi, che indigestione di paillettes. Magari racconto.

Praticamente cinque ore, quanto ci si può mettere da Roma Termini a Fiumicino stando quattro ore e mezza al bar a sentire la musica.
Le compile vere e proprie: inverno 2017 (75 brani, 5 ore) | primavera 2018 (94 brani, 6 ore) | estate 2018 (82 brani, 5 ore) | autunno 2018 (48 brani, 3 ore) | inverno 2018 (133 brani, 9 ore) | primavera 2019 (51 brani, 3 ore) | estate 2019 (107 brani, 6 ore)| autunno 2019 (86 brani, 5 ore)| inverno 2019 (127 brani, 8 ore)| primavera 2020 (102 brani, 6 ore) | estate 2020 (99 brani, 6 ore) | autunno 2020 (153 brani, 10 ore) | inverno 2020 (91 brani, 6 ore) | primavera 2021 (90 brani, 5,5 ore) | estate 2021 (54 brani, 3,25 ore) | autunno 2021 (92 brani, 5,8 ore) | inverno 2021 (64 brani, 3,5 ore) | primavera 2022 (74 brani, 4,46 ore) | estate 2022 (42 brani, 2,33 ore) | autunno 2022 (71 brani, 4,5 ore) | inverno 2022 (70 brani, 4,14 ore) | primavera 2023 (74 brani, 4,23 ore) | estate 2023 (53 brani, 3,31 ore) | autunno 2023 (92 brani, 6,9 ore) | inverno 2023 (76 brani, 4,5 ore) |




















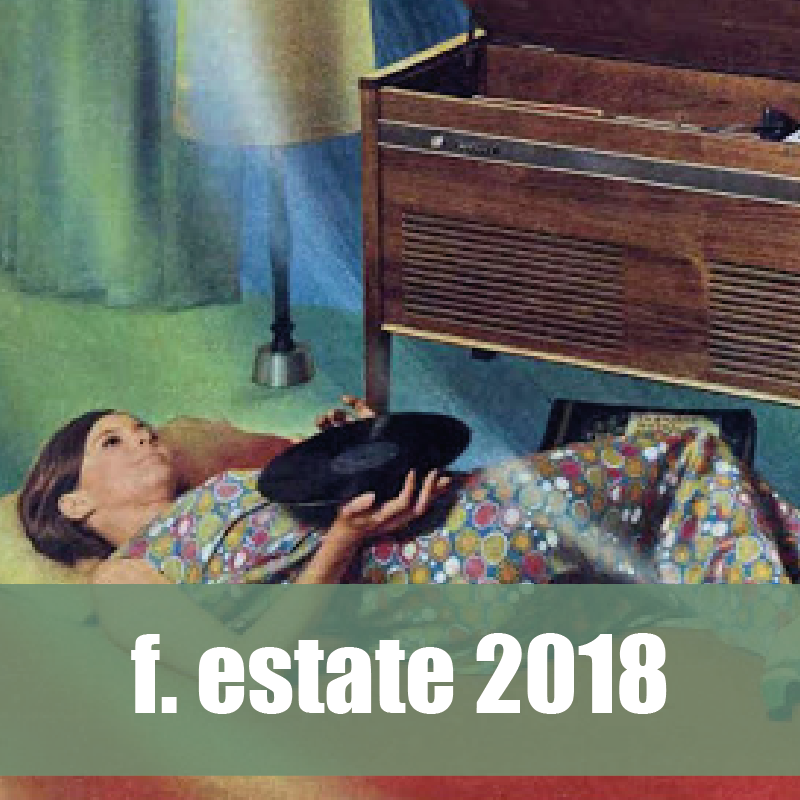



Bravo me, mi dico, che apri le orecchie e sei meno talebano di un tempo. Si migliora, crescendo, eccome. Dentro, almeno, e questo mi basta per compensare. Bon, avanti, allora, che con la primavera siamo già a tre brani e l’estate è là in fondo che già rompe.
Vagolando per le piane a sud di Milano, so per certo e per esperienza che c’è una cintura di abbazie che cinge la parte a sud est della città, tutte risalenti grossomodo ai secoli tra dodicesimo e tredicesimo e legate a quella tipologia padana del luogo agricolo-religioso, talvolta fortificato, che punteggiava tutta la pianura e che ne gestiva coltivazioni, privilegi e commerci. In particolare, tre, ciascuna a un quarto d’ora l’una dall’altra, da ovest a est: Mirasole, Chiaravalle e Viboldone.
Beh, visto che lo so, ci vado. Mirasole ha la struttura più significativa di cascina-abbazia perché fortificata, una grande aia centrale e un tozzo ma arioso chiostro a nord, affiancato dalla chiesa, l’attività particolare era la lavorazione della lana, in particolare la trasformazione in feltro. Che per quanto ne so io, zero, basta lasciarla lì e quella infeltrisce. E poi nessuno mi chiede mai consiglio…

A parte un incongruo balcone con colonnato settecentesco, il complesso è ancora leggibile, sebbene non ne resti moltissimo. Il recupero è stato fatto in modo tradizionale, parecchi ambienti sono affidati ad associazioni più o meno benefattrici, le grandi sale per i corsi, qualcuno ha pensato a un bar ed è stata una buona idea, per il cappuccino seduto al sole nell’aia che mi offro oggi. Secondo me non è un modello sostenibile ma, magari, se qualcuno chiede spiego.
Chiaravalle è certamente la più nota, sia per la discendenza dall’ovvio Bernardo, qui chiamato per frenare le tendenze scismatiche del milanese e riportarlo nell’alveo di papa Innocenzo II a metà del dodicesimo secolo, sia per il funerale di Giorgio Gaber in tempi recenti e per una certa notorietà superiore alle altre due. È anche, fuor di dubbio, la più sontuosa, con la notevole torre nolare (vuol dire che c’è la campana), e la più organizzata, con negozio, ristoro e infopoint.

E frati, qualcuno se ne vede. Scippato il Cristo alla colonna di Bramante, ora a Brera, resta il gran coro ligneo, il chiostro bello e la torre, la ciribiciaccola. Che dice la filastrocca, a un certo punto: Quando i cinquecentocinquantacinque ciribiciaccolini vogliono chiacchierare con la ciribiciaccola / la ciribiciaccola è pronta a chiacchierare con cinquecentocinquantacinque ciribiciaccolini / la ciribicciaccola chiacchiera, i ciribiciaccolini chiacchierano / ma la chiacchierata della ciribiciaccola è più lunga di quella dei cinquecentocinquantacinque ciribiciaccolini. Dilla veloce, dai.
Terza tappa, Viboldone, quasi a Melegnano. Si intuisce il complesso agricolo, enorme, dell’abbazia resta un corpo contemporaneo ancora abitato dalle monache benedettine e la chiesa, di gran lunga l’elemento più interessante. Infatti, all’interno è conservata una serie di affreschi di ispirazione giottesca di grande qualità, riscoperti tra l’altro dalla grande Fernanda Wittgens. Per uno di essi, in particolare, si fa il nome di Giusto de’ Menabuoi che sarebbe il collegamento diretto con la Padova giottesca e la parte a lui attribuita con buona approssimazione è il giudizio universale.

Di impianto tradizionale, al centro Dio nella forma vulvare che tutto sovrintende, a sinistra i buoni e pii scortati dagli angeli amichevoli, a destra un diavolazzo che ingoia gli scellerati e li defeca direttamente nella bolgia, riprendendo in questo gli esempi di Buffalmacco al camposanto di Pisa, il più formidabile che io abbia visto finora, e di Giovanni da Modena nella cappella Bolognini nel Duomo di Bologna. Ma ancor più bello è un particolare in alto, anzi due: due angeli che a destra e sinistra sono intenti ad arrotolare il tempo della storia, facendo intravedere dietro la Gerusalemme celeste. Il motivo è già presente nella cappella degli Scrovegni. Giotto, appunto, tutto torna.

È il giudizio universale, signori, poi si chiude. Si arrotola tutto e bon, arrivederci. Strepitoso. Mi ricorda al volo il Belli de Er giorno der giudizzio: «All’urtimo uscirà ‘na sonajera / D’angioli, e, come si ss’annassi a letto, / Smorzeranno li lumi, e bona sera».
Le altre guide:
adda (risalire da trezzo) | amburgo (tre motivi) | amburgo (le cose vere) | berlino (in sei mosse) | bernina express | bevagna | budapest (gerbeaud) | edimburgo (tre cose per una notte) | ferrara (le prigioni esclusive del castello estense) | glasgow (caffè e tombe) | libarna | mantova (la favorita) | milano (cimitero monumentale) | milano (sala reale FS) | milano (tre abbazie) | monaco di baviera (nazismo e resistenza) | monza e teodolinda | tre giorni in nederlandia | oslo | pont du gard | prietenia: l’ultimo treno sovietico | roma (attorno a termini) | roma (barberini) | roma (mucri) | roma (repubblica) | roma (termini) | da solferino a san martino (indipendenza) | torino (le nuove) | velleia | vicenza (l’illusione della regolarità)
Alle 4:06 di stamane il punto azimutale dell’orbita terrestre incrociata con la fermità solare ha sancito l’accadimento dell’equignomo di primavera che, come dice il nome, apre alla primavera e lascia indietro l’inverno. Se siete tra i savonaroliani che pensano che l’equipozzio avvenga il 21 marzo, cari miei, siete fuori strada: fino al 2102 sarà il 20, a volte il 19, mai ma mai il 21. Così è e non è il caso di star qui a spiegare perché a dei tolemaici dell’accidenti.

Fortuna la primavera arriva sempre, specie quando ci sono i fascisti.
A una decina di chilometri da Glasgow c’è una graziosa cittadina, Paisley, sulle rive del White Cart Water.
La graziosa cittadina ha una graziosa chiesa parrocchiale, l’ovvia Paisley Abbey, che nel dodicesimo secolo sorse su un convento cluniacense per poi diventare, un paio di secoli dopo, una chiesa riformata.

La graziosa chiesa parrocchiale nella graziosa cittadina ogni tanto necessita, come tutte, di qualche restauro, grazioso se possibile. Nel 1990 l’ultimo corposo e complessivo. Vuoi perché son scozzesi, vuoi perché sono nerd, vuoi perché due soldi in più li avevano, vuoi perché i piccoli paesi un’attrattiva turistica se la devono pure inventare, vuoi che diavolo ne so, alla fine, una decina di doccioni dell’ancor graziosa chiesa parrocchiale li hanno rifatti così:

Esatto, l’alieno bavoso di Alien. Sperando non sbavi quella saliva micidiale che tutto corrodeva. Son giochini, è chiaro, ricordo l’astronauta e il drago col gelato di Salamanca e la bicicletta modernista di Barcellona e chissà quanti altri, son giochini. Ma i giochini sono belli, servono e sono meglio dei non-giochini, se mantengono misura e modo. E qui lo fu, direi, tutto sommato. Finché i cosi non si stufano, escono e fanno strage dei paisleyani.
Negli ultimi venticinque anni, il Partito democratico ha governato per 13,5 anni; anche Forza Italia per 13,5 anni; la Lega per 11,5 anni; Fratelli d’Italia per 5,5 anni; il Movimento 5 stelle per 4,5 anni; Sinistra italiana per 3,5 anni. Con alcune inevitabili approssimazioni, unioni e scissioni, il conto è di Alessandro Gilioli.
Ci sono tutti, e non poco, e la colpa di quelli di prima? Di chi ha fatto il buco? Chi sono i ‘prima’? Il colpo di genio, non lo dico io, non è il rimando ma è la catena stessa di colpe, a risalire all’inizio dei tempi, dal dentista al meccanico al governatore. Lo dice Mattia Torre in uno dei suoi brani brillanti, eccolo interpretato da Mastandrea:
Lo riporto, il testo, è molto bello:
È tipico di questo paese: è sempre colpa di un altro. È sempre colpa di quello che veniva prima, di quello che ha fatto il lavoro prima. Che se cambi dentista quello ti visita e fa la faccia angosciata che tu vorresti morire e ti dice: «Guardi, io non parlo mai male dei colleghi, ma qui le hanno combinato un disastro. Tiè, guarda qua che roba». Che tu non hai proprio la scienza per contraddirlo e neanche per dubitare di quello che dice e comunque il problema non si pone perché hai i ferri in bocca e non puoi parlare per cui abbozzi e ti sottometti muto, impotente.
E paghi 1200 euro.
Stessa cosa se ti si rompe il motorino e lo porti da un meccanico che non conoscevi: quello guarda il motore e si mette a ridere; cioè ride proprio: «Chi ce l’ha messe, le mani, qui, eh? Un delinquente ti c’ha messo le mani. Guarda qua che roba», dice la stessa frase del dentista. Stessa cosa con l’idraulico che ti dice che quello di prima ha creato – forse, chissà, apposta – tutta una situazione terribile di calcare per cui è tutto da rifare, stessa cosa con il muratore, che accusa chi ha fatto il lavoro prima di aver usato materiali scadenti e in disuso per risparmiare sulle spese. Quello di prima? Un vero delinquente.
Stessa cosa con il governo appena insediato, che trova un buco di mille miliardi di debito lasciato dal governo precedente, e al precedente governo non gli sta bene che si dica cosi, allora accusa il precedente ancora, che a sua volta accusa il precedente, fino a risalire a un governo talmente indietro nel tempo che sono ormai tutti morti, e che pure, nelle tombe, bofonchiano che la colpa è di quelli di prima.
E tutto il paese va avanti così, in un susseguirsi di truffe di cui è responsabile sempre quello di prima, o quello prima ancora, e comunque mai di chi la fa in quel momento, e questa è una piccola magia tutta italiana, milioni di cittadini e nessuno ha una sola responsabilità… [questa] grande catena di Sant’Antonio è quasi una festa, per tutti tranne per chi viene fregato e si guarda indietro con un vago senso di malinconia, di disagio, perché è impossibile capire da dove la fregatura provenga, forse da altre epoche, da tempi lontanissimi in cui si girava scalzi e si moriva di vecchiaia a trent’anni, ma poi subito gli torna il buonumore, perché una sòla, così come la ricevi, la puoi anche restituire: grandi professionisti noi siamo in questo gioco al ribasso dove vince il più audace e sfacciato «ma si figuri» «fosse per me» «lei l’avrà capito che se dipendeva da me, altroché».
Che significa? Cosa dicono? Non ha importanza. Perché nel frattempo si è sviluppata un’intera comunità di persone fintamente affrante per i disastri commessi da altri, ma subito pronte, se ben retribuite, a riparare il danno. «Ma il danno è grave, eh?» «Non mi faccia mettere le mani avanti.» «Noi qui ci proviamo, non è detto che si risolve.» «Noi proviamo, ma noi non li facciamo i miracoli.» Quando in realtà il miracolo d’ingegno è la catena stessa, per cui già da domani altri interverranno sulla lavatrice, sul motorino, sul premolare o sul governo del paese e ancora una volta diranno: «Qui signori è tutto da rifare, colpa di altri, noi ci proviamo. E speriamo bene».
Ovviamente è colpa di qualcun altro, prima. Noi ci proviamo ma, insomma, non si garantisce. Eppure anche prima erano gli stessi, loro medesimi, è un prima che non contempla sé stessi, un prima astratto che sempre funziona nel riandare a un dove e a un chi che non hanno mai fine.
Canone e premessa imprescindibile: qualunque cosa può essere spiegata in un saggio di non più di cento pagine (iddio benedica ancora i saggi PBE Einaudi, vedi Roland Barthes, Critica e verità, sessantaquattro, 64! pagine) e qualunque storia può essere raccontata in non più delle centosessanta pagine de Lo straniero di Camus.
Tutto il resto è un di più. Augh, ho parlato.
Ma noi no, noi grazie al compiuter, al fatto che non tocca più riscrivere tutto con la macchina, al fatto che si copia e incolla, al fatto che ci si mette meno che a scrivere a mano, noi no: tra i volumi vincitori del premio Strega, nel decennio 1970-1979 la media era di 220 pagine, 292 negli anni Ottanta. Nei Novanta si raggiunge la media delle 317 pagine, dal 2000 al 2009 si va a 337 pagine e avanti con le 471 pagine del decennio successivo. Crescita costante e senza freni, santoddio guarda questo, ma che dovrà dire uno in quattrocento pagine? Chissei, Proust? Per non citare i due più verbosi di sempre, M. Il figlio del secolo (848 pagine) e La scuola cattolica (1.294 pagine), qualcuno abbia pietà di noi. Di me, almeno.
La tendenza è confermata ovunque, il Booker Prize, analizzato dalla critica britannica Leaf Arbuthnot: 248 pagine nel 1970, 294 nel 1980, 372 nel 2000, 530 nel 2019. Il che ha suscitato un vivace dibattito all’interno del premio stesso. E sì che la controtendenza di video e social invece sembrerebbe portare alla riduzione, non all’ammasso di concetti.
Marketing con prodotto un tanto al chilo, mancanza di editor (vedi il grande Vittorini, a breve prometto racconto la storia del Sergente nella neve) in grado di tagliare e farsi valere, facilità tecnica come accennato, ristampe più visibili alla lettura (Il nome della rosa cresce invariabilmente a ogni edizione, curioso) e così via, le spiegazioni possono essere parecchie e presumibilmente concomitanti. Segnalo un bell’articolo al riguardo su Treccani.it di Giacomo Natali da cui ho tratto i dati e qualche conclusione.
Lo dico? Sì, oramai scelgo le mie letture guardando il numero di pagine. Se l’argomento è la storia dell’universo posso arrivare a leggere anche duecento pagine, se l’argomento è un giallo a camera chiusa o le vocette di Meloni allora mi spiace, mi ritiro poco dopo le ottanta. Che sarebbero già tante.
Ascolto Night Passage dei Weather Report, poi arriva la cinque, Rockin’ in Rhythm, ed oltre a essere un ottimo pezzo mi ricorda qualcosa. Fischietto per farmi venire in mente il prima e il dopo, riascolto, nel frattempo cerco qualcosa in più e scopro che è di Duke Ellington con Harry Carney e Irving Mills del 1931. In particolare, c’è un passaggio che mi rimanda ad altro, qui a 1:53. Fischietto fischietto canticchio e poi mi viene in mente, finalmente: Grande figlio di puttana degli Stadio (e Dalla). Alla fine, da 4:25 con lo stesso tipo di suono, direi praticamente citazione. Ci sono riuscito senza gugol e lavorando allo stesso tempo, bravo me, ammesso che qualcuno abbia mai notato questa cosa. Penso francamente di essere il primo, inutile cercare in rete.