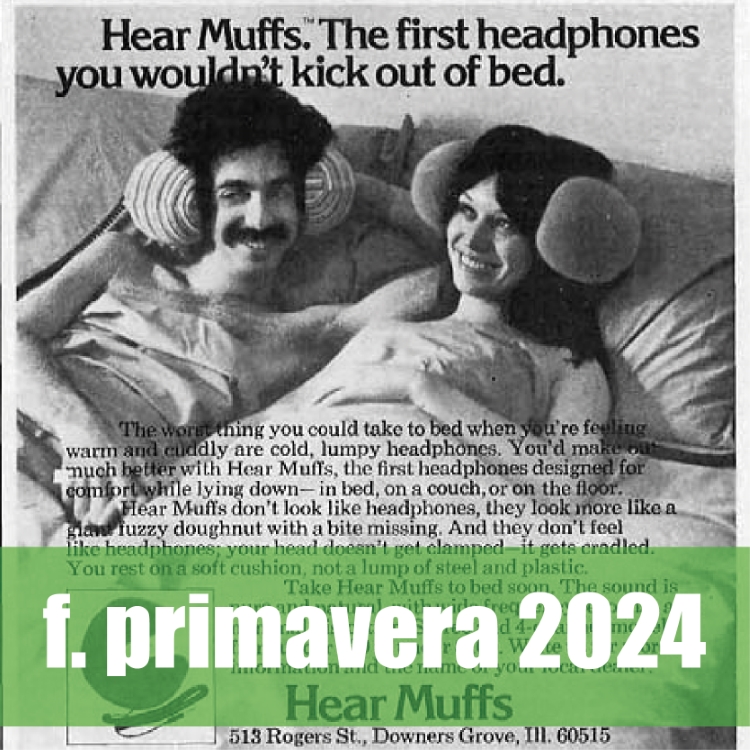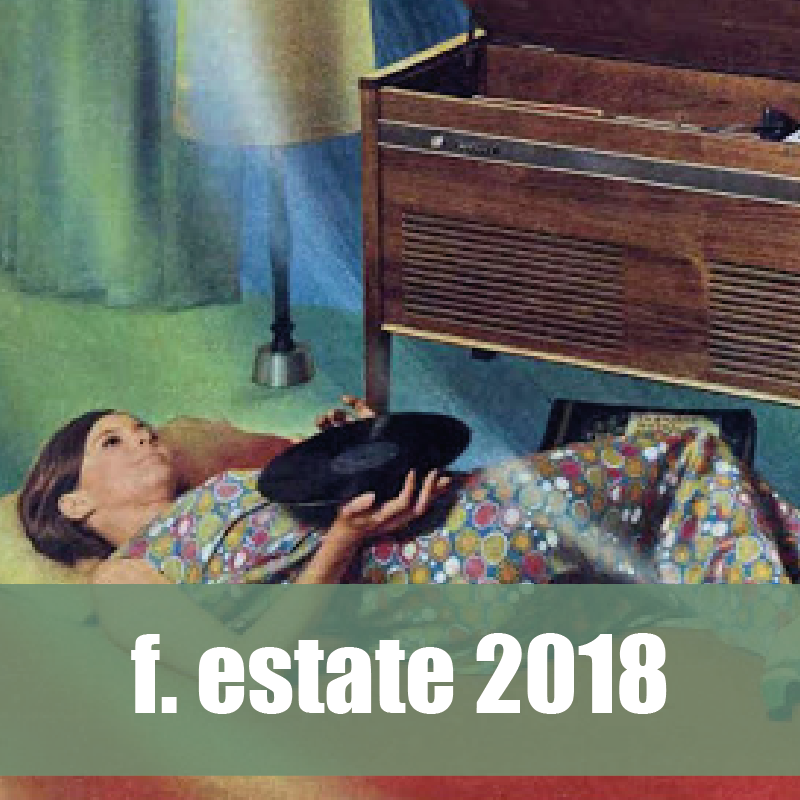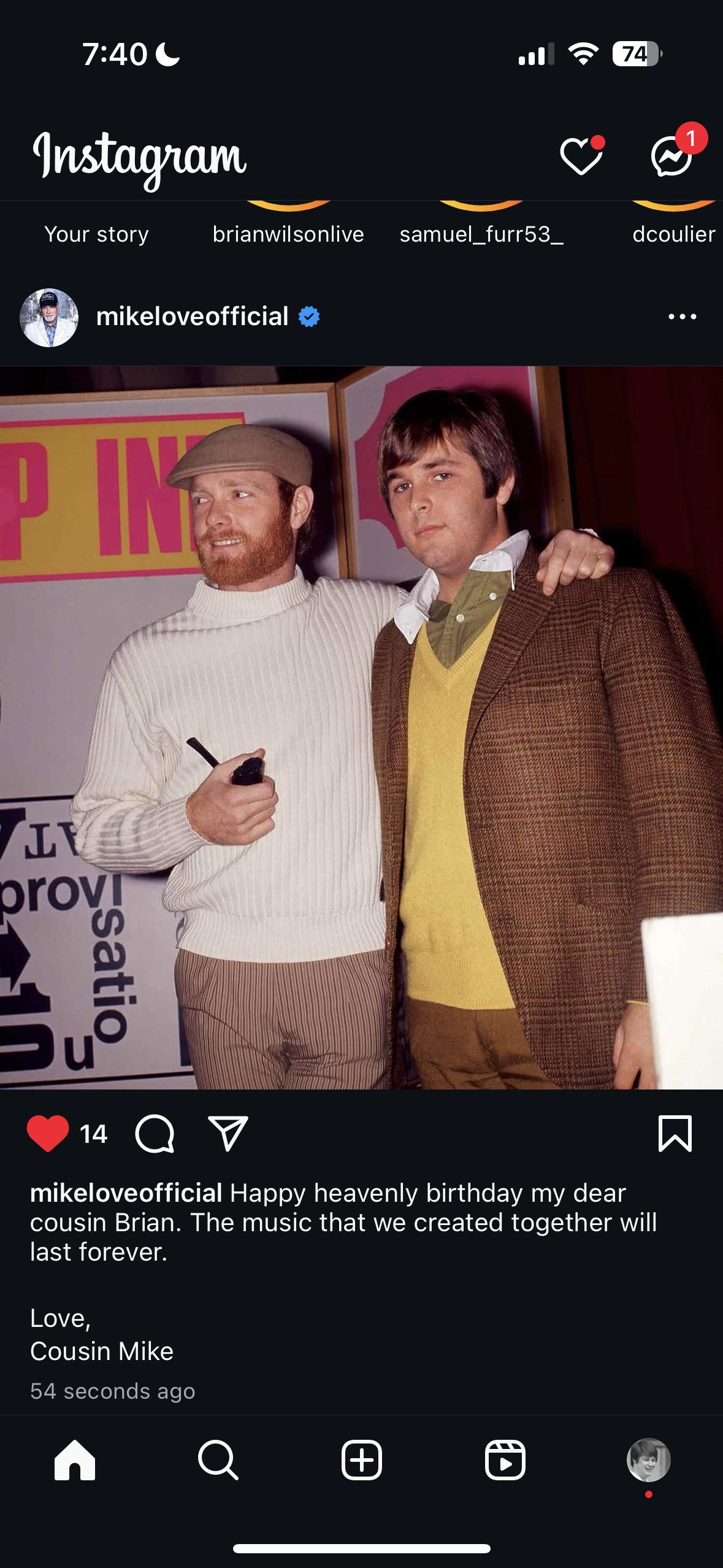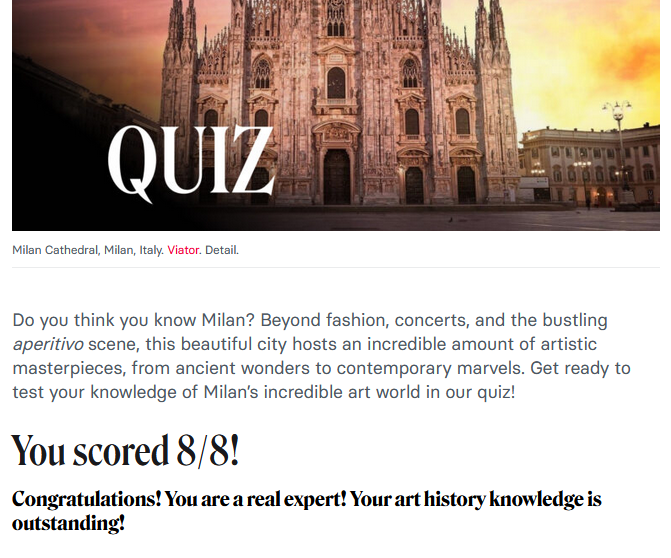Daniel Ek, fondatore e signore di Spotify, ha deciso di spendere una parte congrua dei nove miliardi e rotti di dollari del suo patrimonio in armi.

Helsing è una delle aziende emergenti nel panorama europeo della difesa. Fondata nel 2021 in Germania, la società sviluppa software militari basati su intelligenza artificiale per l’analisi in tempo reale di dati provenienti da sensori e sistemi d’arma. Dal 2023, ha iniziato anche la produzione di droni da combattimento, tra cui il modello HX-2, già impiegato nel conflitto in Ucraina. Secondo Helsing, l’obiettivo è contribuire all’autonomia strategica dell’Europa riducendo la dipendenza da tecnologie non europee.
Con tutto il mio entusiasmoooah, stavolta sono pienamente d’accordo con Piero Pelù che ha affermato: «Visto che la Musica da cui il suddetto succhia i suoi profitti giganti parla oltre che di mille cazzate anche di amore per la vita, di rispetto per l’ambiente, di Pace, noi poveri ingenui abbiamo pensato che questi nuovi investimenti (600.000.000 seicento milioni di €) andassero alla ricerca per il cancro o alle Ong che salvano vite in posti di guerra o in mezzo ai mari, oppure alla costruzione di macchine che liberino i mari dalle microplastiche che ci avvelenano ogni giorno di più» e condivido il nesso e la causalità tra ciò che commercia, la musica, e i fini con cui investe ciò che guadagna. Va quindi presa una posizione, per quanto mi riguarda, da abbonato. Da rilevare che il mondo musicale, almeno quello italiano attorno a Pelù, anche se sollecitato tace.
Un tempo, in tempi migliori dal punto di vista della consapevolezza collettiva, ci si sarebbe fatti sentire, tempestando la segreteria di Spotify di proteste minacciando la dismissione degli abbonamenti finché il capo non avesse capitolato, rientrando dalla scelta avventata. Oggi invece viviamo in tempi individuali e individualistici, per cui toccano anche risposte individuali, sicuramente di minor effetto. Quindi: o non fare nulla, come quasi sempre, o protestare minacciando, o prendere provvedimenti. In questa ultima ipotesi, da un primo sguardo le prime opzioni alternative per catalogo paragonabile mi paiono Deezer e Tidal. Se queste due ultime offrono senz’altro una migliore qualità del suono, oltre mille kbit di bitrate rispetto ai modestissimi trecentoventi di Spotify, e interfacce equivalenti se non migliori, sono senz’altro inferiori per algoritmi capaci di suggerire ascolti analoghi – e quindi, in definitiva, di scoprire musica nuova -, offerta di podcasts e funzioni social. Non indifferente, la questione della proposta di musica affine, almeno per il mio tipo di uso. Deezer e soprattutto Tidal, proprietà in parte di musicisti da Jay-Z in giù, se è ancora così, offrono migliori retribuzioni agli artisti, il che ha un suo significato non da poco, e i ricavi personali di Ek un po’ lo dimostrano. Entrambe le piattaforme propongono un servizio di importazione delle playlist da Spotify e sono entrambi a pagamento oltre le cinquecento canzoni per playlist. Da valutare. Deezer, infine, ha una versione gratuita mentre Tidal no, propone un mese gratuito. Non ultimo, visto il punto di partenza del ragionamento: la proprietà di Deezer è di Access Industries, che si occupa di: «biotechnology, entertainment, external funds, global media, strategic equity, technology ventures, and real estate», quindi forse siamo daccapo; da Tidal è uscito nel 2017 Kanye West, il che è solo bene; la compagnia è in maggioranza di proprietà di Block, Inc., in cui si ritrova Dempsey di Twitter e che ha larghi interessi in forme di pagamento e mining di criptovalute, lui un aspetto ideale l’aveva e non pare avere a che fare con il mercato delle armi.
I servizi di audiostreaming sono decine – qui una tavola di comparazione, di Amazon music, Youtube music, Apple music eccetera non mi occupo proprio – e i fattori di scelta sono numerosi e non tutti determinanti. Se per i podcast io avevo risolto così, qui tocca fare un ragionamento più esteso: per quanto mi riguarda, di sicuro la caratteristica principale di Spotify fin dall’inizio, ovvero l’istantaneità, ottenuta con un complicatissimo sistema misto di p2p e chiamate al server, è persa, a volte ci mette un bel po’ a partire. E l’app mangia una quantità di batteria considerevole. Cose comunque da verificare anche in ogni altro servizio. Devo ancora studiare SoundCloud che è, peraltro, il servizio con il catalogo più grande del mondo ma che, da quel che so, è più orientato verso i creatori di musica. Non male, comunque, oltre duecento milioni di brani, figuriamoci, bastano appena.
Ma il punto, qui, restano le armi. E viva Pelù, lo dico. Ora devo dirlo alla mia famiglia di Spozzifai.