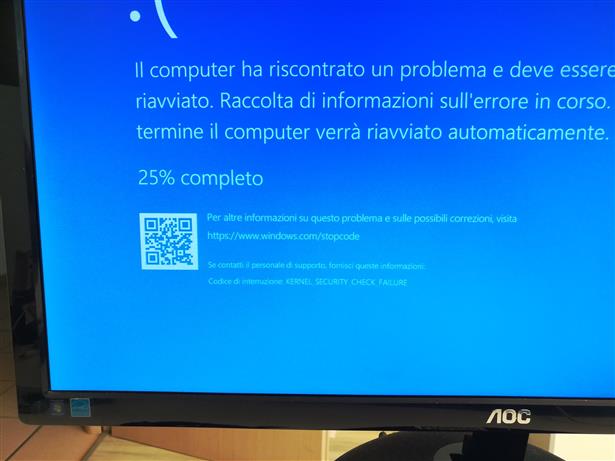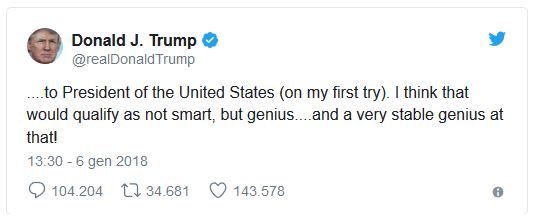Nel 1996 la storica Deborah Lipstadt, durante una conferenza sull’olocausto, fu interrotta da David Irving, saggista inglese, che la accusò di propagandare falsità: secondo Irving, infatti, non vi erano prove che la soluzione finale fosse stata ordinata da Hitler e, anzi, si spinse anche più in là, sostenendo che non vi fossero prove che i campi di concentramento avessero effettivamente dei forni crematori destinati allo smaltimento dei cadaveri. Un negazionista. Alle rimostranze di Lipstadt, che lo definì «un negazionista», Irving rispose querelando lei e la sua casa editrice, la Penguin.

Secondo il diritto anglosassone, toccò a Lipstadt e Penguin dimostrare la propria ragione e, di conseguenza, dimostrare in un’aula di tribunale l’effettiva consistenza e avvenimento dell’olocausto. Nessuno ci aveva mai pensato prima: dover dimostrare un fatto così eclatante, gigantesco e mostruoso di fronte a una corte e, soprattutto, con gli strumenti di avvocati e giudici, si rivelò una faccenda davvero molto complessa e dai risvolti incredibili.

Gli avvocati difensori di Lipstadt, per fare un esempio, decisero di non farla parlare e, ancora più stupefacente, di non far parlare nemmeno i sopravvissuti: una causa in tribunale si gestisce, infatti, su altri piani e con altre regole. Per una storica, la cosa divenne rapidamente incomprensibile. Ma si fidò e vinse: il che vuol dire – non banalmente – che dal 2000 l’olocausto è anche una certezza giudiziaria, che non può essere negata. Irving fu riconosciuto colpevole non solo di calunnia ma, più tardi, di negazionismo e di aderenza a formazioni di estrema destra, oltre ad aver «per le sue ragioni ideologiche continuativamente e deliberatamente manipolato e alterato l’evidenza storica».

Dalla vicenda, Lipstadt ne trasse un libro importante, «History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier» (in italiano, «La verità negata. La mia battaglia in tribunale contro chi ha negato l’Olocausto», 2016, Mondadori) e, a sua volta, da esso fu tratto un film, «Denial», «La verità negata», ben scritto e girato con ottimi attori (un bel pezzo del cast di Sherlock).
Credo sia un buon modo per ricordare, oggi, e per capirne un pezzetto di più: dover dimostrare l’effettiva esistenza dell’olocausto in un tribunale si è rivelato un compito difficile e arduo, una ragione in più per mantenere viva la memoria su ciò che è stato.