Il London Bridge, quello di Geordie e dei cervi del parco del re, quello che cade, fu l’unico ponte di Londra per un sacchissimo di tempo, prima romano e poi medievale.
Probabilmente è il più famoso ponte sul Tamigi e se state pensando a delle torri, allora state pensando al Tower Bridge, più famoso oggi ma molto più recente.
Comunque, essendo ormai inservibile il vecchio ponte medievale, causa ridotte dimensioni e una notevole superfetazione di edifici sul ponte stesso, nel 1824 si decise di costruirne uno nuovo in luogo di quello storico, e così fu. Anche il nuovo ponte, il cosiddetto ‘Ponte di Rennie‘, si rivelò presto inadeguato, perché ebbe la malaugurata idea di cominciare a sprofondare nelle limacciosità del fiume. E fu così che negli anni Sessanta, ieri, fu inaugurato il terzo ponte, il London Bridge di oggi.
Che uno quando va a Londra e gli vien voglia di vedere il famoso London Bridge delle canzoni ci va e poi commenta: “apperò, bel cesso, me lo immaginavo meglio“.
Il ‘Ponte di Rennie’ non fu però distrutto, ma smontato, numerato accuratamente e rivenduto nel 1968 al signor americano McCulloch, il signore delle motoseghe.
Il signor McCulloch se lo portò via pezzo per pezzo e lo rimontò in Arizona, a Lake Havasu. Narra la leggenda che il signor McCulloch fosse convinto di aver comprato il Tower Bridge e che abbia scoperto l’errore solo una voltà là, ma l’interessato (ovviamente) nega e va bene americano ma pirla del tutto forse è davvero eccessivo.
Il London Bridge fa bella mostra di sè oggi in Arizona, come detto, in una bella cornice per nulla appariscente ed elegante invero:

Qui dal vivo. Americanata? Forse, anzi probabile. Gli è che il signor McCulloch non si limitò al ponte ma ci costruì attorno tutta una cosa tipo parco tematico in stile inglese – e per stile inglese si intenda il poco coerente stile Tudor – che oggi è la seconda attrazione dell’Arizona, battuta solo dal Gran Canyon. Imperdibile il London Bridge Resort, con vista sul ponte: ecco qua.
E fu così che il ponte che viaggiò per 8774 chilometri si gode ora la sua nuova celebrità come maggiore attrazione di uno splendido parco tematico per ritardati amanti della vecchia Europa.


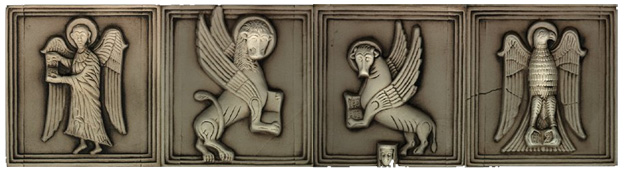


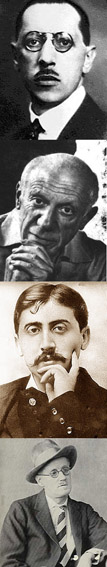
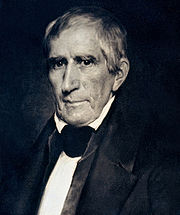
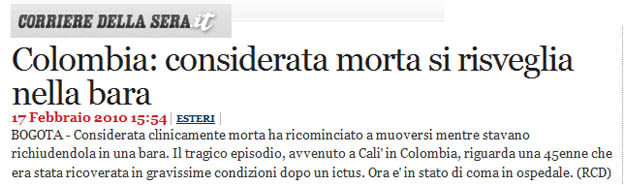
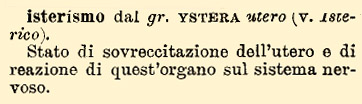 Il che mi serve, tra l’altro, come pretesto per rimandare a
Il che mi serve, tra l’altro, come pretesto per rimandare a